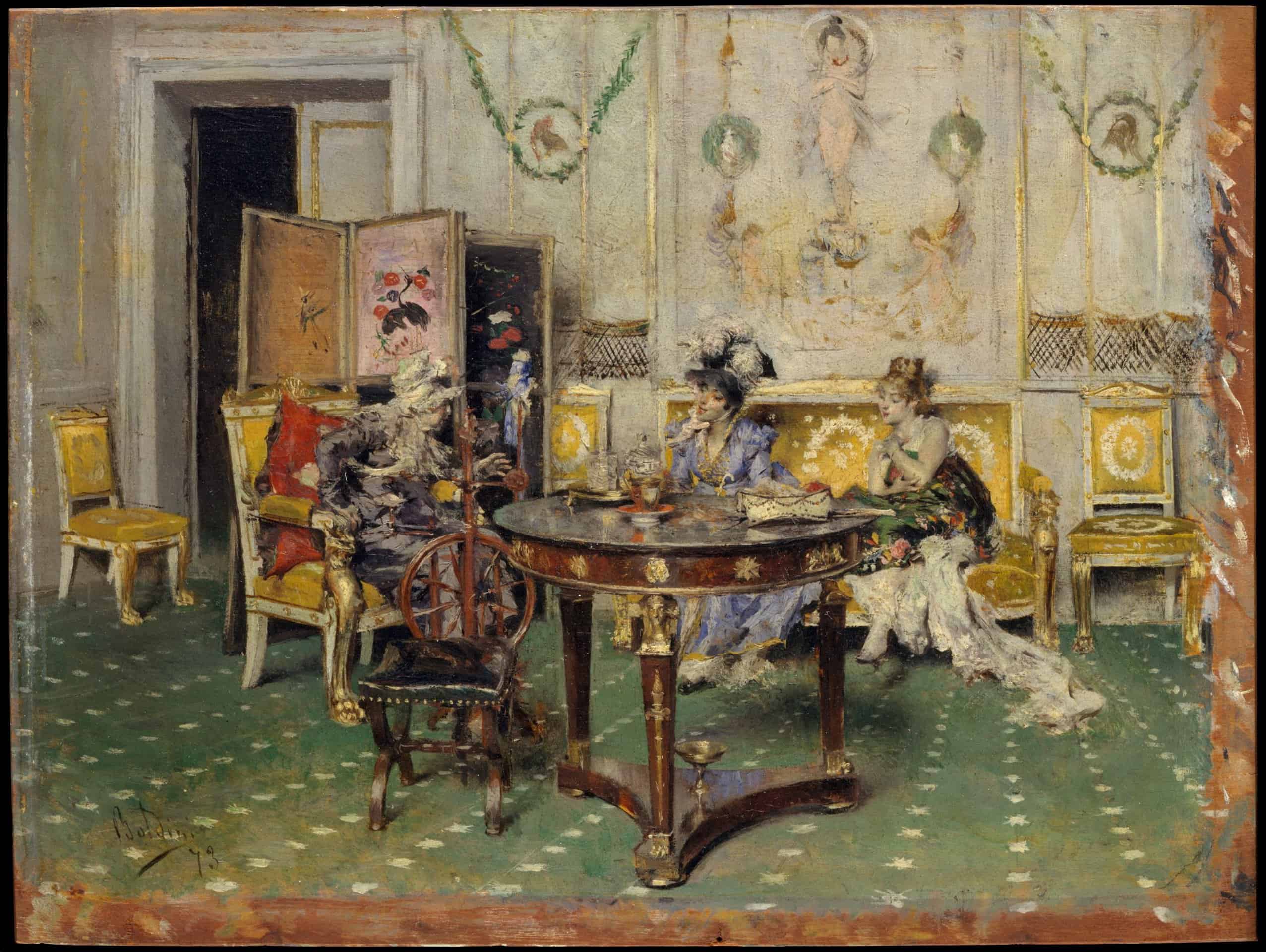Ho già toccato altrove la questione, ma tocca tornarci per un caso specifico e per farlo ci vuole una piccola premessa. So che per i cattolici d’oggi è difficile trovare uno spazio politico; non per niente sono cattolico anche io. Un tempo le cose erano più facili: c’era la DC, che di cattolico non aveva neanche ben il nome, e si vendevano delle straordinarie pinzette per turarsi il naso. Oggi le fabbriche di pinzette sono in crisi, ed è comprensibile che l’elettore provi ad orientarsi dove puzza di meno; questo però non lo autorizza a dire baggianate, soprattutto sui morti, che non hanno modo di difendersi.
Ma qual è la baggianata in questione? Che da sempre non esistono destra e sinistra, ma conservatori e progressisti, e che questo valga in particolare per la cultura. Anzi, si spinge oltre: da Dante a Pasolini la nostra letteratura, a parte qualche raro caso come Boccaccio e Leopardi, notissimi progressisti, sarebbe conservatrice.
Ora, si potrebbero dire molte cose a riguardo; ad esempio che è difficile considerare come conservatore un creativo, che di solito ha un’idea tutta sua e originale di come sono e di come dovrebbero essere le cose; oppure che è difficile considerare un tale che scrive un’opera destinata a durare nei secoli un progressista; o ancora che la nozione di progresso è un’invenzione parecchio recente, e lo stesso per quella di conservatorismo. E questi sarebbero tutti discorsi estremamente sensati se si stesse parlando con qualcuno che non si inventa argomenti pro domo sua senza aver neanche ben letto Cicerone. Purtroppo non è il nostro caso.
Ora non credo che chi ha cominciato a fare queste distinzioni abbia agito in malafede, ma penso che la sua fantasia sia stata stimolata nella sua pare più creativa da delle convinzioni profonde ed ingenue (in quanto non approfondite nella realtà). Questo non rende meno sbagliate le sue conclusioni, dato che provengono da delle premesse sbagliate e, forse, ancora peggio, da un metodo machiavelliano e opportunista; piuttosto crea delle aporie al limite della comicità, anzi, alcune la superano a grandi passi.
Ora, Dante si può, stiracchiando un po’ la definizione, definire conservatore, e di destra in quanto fan sfegatato della monarchia; si potrebbe notare che questo è perché Dante è stato modello per molti conservatori, e non che i conservatori abbiano ispirato lui con cinque secoli di anticipo, ma non lasciamoci frenare da queste quisquilie. Nell’elenco degli autori “conservatori”, però, il nostro volenteroso scribacchino ha infilato dei nomi che per lo meno fanno alzare un tantino il sopracciglio, se non proprio scoppiare in una sonora risata.
Machiavelli conservatore? A quale titolo? Forse ci si riferisce ad alcune sue poco lungimiranti idee ne “L’arte della guerra”; forse al suo cieco autoritarismo espresso nel “Principe”; di certo né alle sue idee politiche, né al suo apporto culturale, che se dovessimo in qualche modo valutare, sarebbero piuttosto vicini all’estremità opposta dello spettro.
La presenza, però, in questa lista che lascia un tantino più sbigottiti, è, udite udite, D’Annunzio. Sia chiaro, D’Annunzio, al Vittoriale, ha conservato molte cose, ma non basta questo a farne parte di una certa fazione politica, o tutti gli accumulatori compulsivi voterebbero a destra. Non si capisce cosa abbiano di legato al conservatorismo il mito dell’aereo, il libertinaggio, e soprattutto l’avventura fiumana, con tutte le sue caratteristiche più vicine a Port Royale che a Roma.
Ma attenzione, ci avverte il nostro anfitrione digitale, il metro per misurare il conservatorismo è il rapporto con Dio o con l’Assoluto; è questo il criterio con cui D’Annunzio è stato messo tra i conservatori, e Leopardi tra i progressisti. Non conta nulla che Leopardi abbia criticato “le magnifiche sorti e progressive”, che si sia dedicato in modo intensivo ai classici, che il suo stesso pessimismo lo allontanasse totalmente dai sogni giusnaturalisti e scientisti che andavano di moda alla sua epoca; non era cristiano, ergo diventa automaticamente progressista. Poco importa che avesse, di fatto, un rapporto tormentoso e complesso con l’assoluto, frenato da uno scetticismo ironico e spinto da un desiderio irrefrenabile, come testimonia in Alla sua donna, il consiglio ha decretato la sua scomunica. D’Annunzio, invece, da buon cristiano ebbe una vita estremamente sregolata, volta al culto di sé; come molti cristiani tirò fuori Dio e l’assoluto solo quando doveva mettersi in buona luce e gli era di comodo, lasciando tutto il resto della sua esistenza e della sua produzione ad un nietszchanesimo edonista e personalizzato.
Se però la questione è il rapporto con l’Assoluto, come ci finisce Carducci, col suo Inno a Satana, tra i conservatori? Quanto a Pasolini, ci viene comunicato che ha avuto un lasciapassare per il gruppo dei “buoni” in quanto espulso da PCI e antiabortista. Quanto ad Arioso e Lorenzo De Medici, si sono probabilmente seduti dalla parte dei progressisti perché tutti gli altri posti erano occupati.
Si potrebbe continuare a smontare, pezzetto per pezzetto il piccolo post che ho preso ad ispirazione, ma il bullismo, come tutti i giochi, è bello quando dura poco. Sarebbe però un vero peccato sprecare l’occasione di porre un punto su questi giochetti un tantino imbarazzanti.
Si potrebbe dire in modo molto semplice che non ha senso dividere la storia in due sole fazioni, soprattutto se lo si fa a posteriori; in questo modo si corre però solo il rischio che l’illuminato redattore della storia della letteratura in un post di dodici righe crei la categoria “Altro” per schiaffarci quelli di cui non sa cosa pensare e andare avanti. Ora, viene da chiedersi se, piuttosto, è davvero così necessario dividere la cultura tra buoni e cattivi, progressisti e conservatori. San Basilio ci insegnava a prendere le rose dal roseto della letteratura pagana, stando attenti a non pungersi con le spine; perché non applicare questo criterio anche a quella di oggi?
Questo tralaltro non si capisce perché non dovrebbe funzionare anche al contrario. Se abbiamo qualcosa da dire, sarebbe opportuno rivolgersi al mondo intero, non a chi già la pensa esattamente come noi. Siamo chiamati ad essere martiri, testimoni, non lutulenti accademici. Per fare ciò, sarebbe buona cosa abbandonare queste autopacche sulle spalle e iniziare a vedere quali sono le cose grandi e buone che si possono condividere, cosa che tralaltro produrrebbe risultati molto meno noiosi di questa autocelebrazione postuma.
Samuele Baracani: nato nel 1991, biellese, ma non abbastanza, pendolare cronico, cresciuto nelle peggiori scuole che mi hanno avviato alla letteratura e, di lì, allo scrivere, che è uno dei miei modi preferiti per perdere tempo e farlo perdere a chi mi legge. Mi diletto nella prosa e nella poesia sull'esempio degli autori che più amo, da Tasso a David Foster Wallace. Su ispirazione chauceriana ho raccolto un paio di raccontini di bassa lega in un libro che ho intitolato Novelle Pendolari e, non contento, ho deciso di ripetere lo scempio con Fuga dai Faggi Silenziosi.