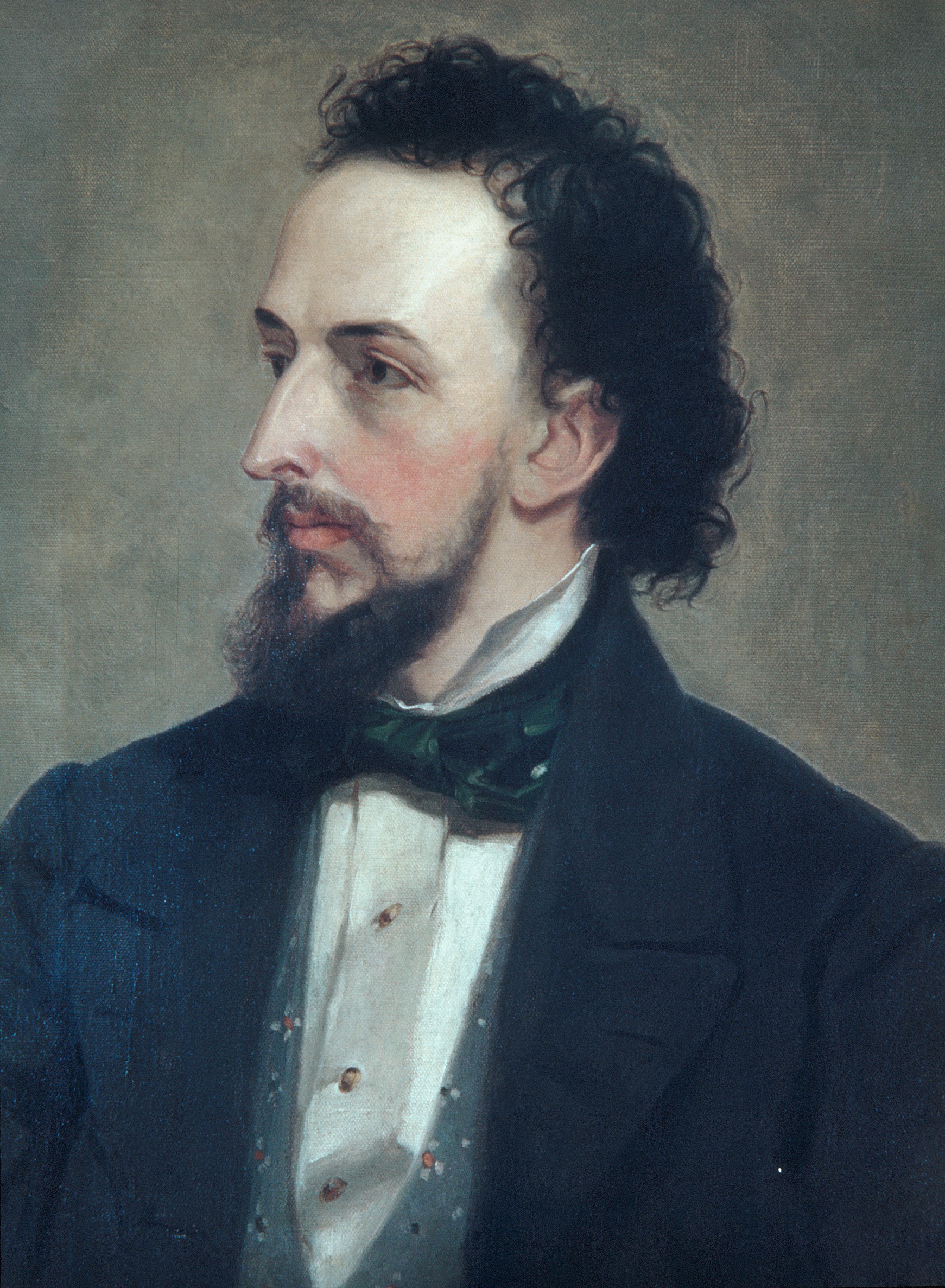Anni fa’, leggendo il Circolo Pickwick, mi ritrovai davanti a una prefazione o una nota che sosteneva che si trattava dell’opera meno dickensiana di Dickens, il quale, poveretto, per piacere al pubblico, aveva potuto parlare delle cose che gli interessavano davvero solo nei capitoli finali del libro. E quali erano gli argomenti di cui davvero voleva parlare? Ovviamente le questioni sociali della sua epoca (in questo caso particolare, lo stato delle prigioni per debiti), caricate del consueto forte pathos dickensiano.
Le sopracitate parti erano ovviamente le più noiose e meno interessanti di tutte le settecento pagine e fischia del libro, a parte la prefazione ovviamente, il che ci farebbe ringraziare in ginocchio l’intervento del pubblico che, frusta alla mano, ha costretto l’autore vittoriano a ridurne lo spazio, se quello fosse davvero il vero Dickens. Ma lo è?
Se ci limitassimo a leggere le trame delle opere, ci troveremmo costretti a rispondere di sì. A parte rarissimi casi che deviano nelle più svariate direzioni, le situazioni in cui il vecchio Charles ambientava le sue storie sono decisamente strappalacrime, con tutto il loro corredo di povertà, orfani e poco allegre combriccole. Se procedessimo a leggere la critica non saremmo colpiti da nulla di diverso, come la prefazione che avevo letto al tempo testimonia. Ma cosa accadrebbe se leggessimo proprio quello che Dickens ha scritto? Pare scandaloso, ma anticamente questo era il modo in cui si valutavano le opere letterarie e soprattutto i giudizi su di esse.
Ora, se l’umile penna di un signor nessuno può confrontarsi con quella di grandi critici, io credo di poter dire da lettore che ridurre il Circolo Pickwick a due grandi blocchi contrapposti sia una colossale fesseria. Chi fosse il vero Dickens forse non lo sapeva neanche lui stesso, ma di certo sapeva di avere più di due dimensioni; ancora di più forse sapeva che una delle sue dimensioni dipendeva dal rapporto con gli altri, ovvero nel caso di uno scrittore col suo pubblico.
In primo luogo va notato che, per quanto ancora impefettamente nel Pickwick, Dickens ha sempre moderato estremamente il suo pathos con una più o meno sottile ironia e con un certo senso dell’umorismo. Le descrizioni dei personaggi malvagi nelle sue opere sono ben lontane dal patetismo che gli si vorrebbe attribuire tout court, ed anzi fanno satira e caricatura. Si potrebbero tirar fuori una marea di esempi: il signor Comitato che non riesce a capacitarsi che un orfano osi chiedere ancora zuppa; la matrona arcigna che fa opere di carità solo per sentirsi superiore a quelli che aiuta; lo stesso signor Scrooge, divenuto il modello di Paperon de Paperoni. Si tratta di uno stranissimo equilibrio, ma non sarebbe sbagliato dire che le opere dickensiane hanno un carattere di realismo comico. Prendono in giro la meschinità umana descrivendola in modo a volte iperrealistico e mostrandone l’assurdità.
Ancor di più però occorre capire che ogni autore è modellato e mosso dal rapporto col proprio pubblico; non ne è ricattato, ma ammaestrato e guidato. Il genio del creativo può spingerlo quanto vuole verso l’originalità e dunque il romitaggio, perché il genio duro e puro, in tutta la sua unicità, non può che essere incompreso. Quale artista però vuol essere una Cassandra inascoltata? Che senso avrebbe un’arte così nuova che nessuno potrebbe comprenderla? Gridare nel deserto è roba da profeti, non da poeti; ai poeti non piacciono particolarmente le locuste e ne ho visti ben pochi vestirsi di peli di cammello; nessuno scrittore squattrinato, per quanto eccentrico, si è mai messo a battezzar gente nel Giordano, e Dickens non lo fece neanche nel Tamigi. Forse Orwell avrebbe potuto farlo, ma non era cristiano e probabilmente neanche uno scrittore.
Insomma, per campare, o anche solo dar senso alla loro arte, gli artisti devono avere un pubblico e avere un pubblico è una cosa che cambia. Non si tratta di un ricatto; non si tratta soltanto di dare al pubblico il contentino e poi fare il predicatore; il fatto è che il creativo vuole piacere, anzi, vuole intrattenere. L’artista è una persona che deve fare un regalo di compleanno e non vuole assolutamente che basti il pensiero: vuole vedere un sorriso di gratitudine sincera nel festeggiato. Perché ciò possa avvenire, deve conoscere e capire il suo pubblico, ma soprattutto deve condividere l’amore per il regalo, o finirà col mancare il segno.
Detto in altre parole, il creativo condivide con il suo pubblico quello che qualunque essere umano dotato di ragione chiamerebbe un rapporto, e un filosofo settecentesco un contratto. E questo rapporto o contratto, come ogni relazione, lo costringe ad ampliare le proprie vedute: il pubblico è ciò che controbilancia il suo estro e gli impedisce di diventare pazzo o, peggio ancora, un giornalista, ovvero la versione moderna del profeta che le locuste vuole che le mangino gli altri. L’artista ha un estremo bisogno di questo rapporto per essere completo e per questo mette la sua opera in esposizione o sul mercato; ha bisogno che quello che sta a cuore al pubblico integri quello che sta a cuore a lui, e spesso ha bisogno che il suo pubblico sia fatto di gente comune per poter essere riportato coi piedi per terra. Ne consegue quindi, a voler essere pignoli, che il vero Dickens è quello che abbiamo e non solo la parte che non piaceva al suo pubblico…
Samuele Baracani: nato nel 1991, biellese, ma non abbastanza, pendolare cronico, cresciuto nelle peggiori scuole che mi hanno avviato alla letteratura e, di lì, allo scrivere, che è uno dei miei modi preferiti per perdere tempo e farlo perdere a chi mi legge. Mi diletto nella prosa e nella poesia sull'esempio degli autori che più amo, da Tasso a David Foster Wallace. Su ispirazione chauceriana ho raccolto un paio di raccontini di bassa lega in un libro che ho intitolato Novelle Pendolari e, non contento, ho deciso di ripetere lo scempio con Fuga dai Faggi Silenziosi.