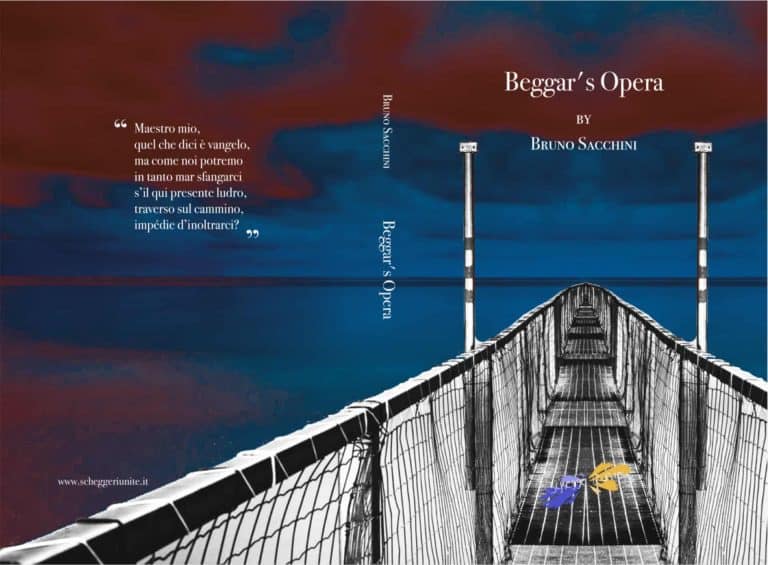E ora che avevo cominciato
a capire il paesaggio:
«Si scende,» dice il capotreno.
«È finito il viaggio.»
Il tema del viaggio, nel racconto di Howard Phillips Lovecraft La ricerca onirica dell’ignota Kadath, pervade l’intera trama della storia ed è a fondamento della sua struttura.
Ora, che il tema del viaggio sia metafora di un peregrinare interiore dell’eroe è quanto mai assodato e trova i suoi esempi principali nei miti e nelle fiabe nonché nelle saghe medievali, che assumono questo topos in innumerevoli forme. Il racconto di Lovecraft ne è quindi un epigono, quello che de Rougemont vedrebbe come uno scadimento, più che una ripresa, nelle forme narrative moderne di un sapere popolare ancestrale. Il racconto del viaggio di Carter verso la sua meta è però significativo, nel suo modo di compiersi, di quanto il viaggiare in epoca moderna sia divenuto per come ne tratteggia le caratteristiche Michel de Certeau.
Carter è il viaggiatore descritto da Certeau nella sua opera Inventare il quotidiano; costretto – come il protagonista mentre è obbligato pur senza gangli – nella galea nera. “Immobile nel vagone ferroviario, il viaggiatore, recluso, vede scivolar via le cose immobili. […] Fermi al loro posto, i passeggeri sono sistemati, numerati e controllati negli scompartimenti. […] tutto è irregimentato”. Questi brani tratti dal capitolo VIII intitolato Navale e carcerario – termini perfettamente attinenti alla galea -, trovano una similitudine nella condizione del nostro eroe: “Carter riprese coscienza circondato da odori tremendi, sotto ad un telo simile ad una tenda sul ponte di una nave, alla vista delle stupende coste del Mare del Sud che scorrevano con incredibile sveltezza. Non era in catene, ma tre di quegli scuri mercanti gli stavano accanto sogghignanti”.
Ma il punto di congiunzione determinante tra le due situazioni è dato dal fatto che noi come lui, mentre costretti viaggiamo, nel contempo vediamo qualcosa: le cose immobili, le coste del Mare del Sud. Il vedere è così determinate nel racconto di Lovecraft che è il mcguffin, la causa scatenante per la partenza di Carter che anela la meravigliosa “Città del tramonto”, vista in sogno e ora insopportabile nella sua lontananza. Il vedere, compresi tutti i suoi derivati, sinonimi e compagni di sfera semantica, pervade da cima a fondo il racconto. Costante in ogni pagina, spesso questo vedere è sempre un passare affianco, senza mai tangere o modificare, quella realtà osservata: “Spossessamento della mano a vantaggio di un più grande percorso dell’occhio”, sempre Certeau. Vede città, a volte dai tratti usuali spesso favolose e raccontate quasi sempre con una riga o forse meno, come fossero incipit o appunti lasciati a Calvino, per le sue di città; e vede una collezione di animali tale da comporre un bestiario non indifferente di pura immaginativa lovecraftiana: esseri fantastici e improbabili: agghiaccianti, impensabili… A questi si accompagnano animali comuni e terrestri quali rospi, zebre dalle grandi qualità di trasporto cose e persone, gatti. Gatti soprattutto, gatti di mille colori e specie, che conoscono mondi sconosciuti e mai visti da nessun altro, mondi segreti – segreti forse al pari del loro terzo nome, come notò Eliot -, mondi racchiusi nei loro occhi – come noterà dalla sua Guccini.
“Il treno generalizza la Melancholia di Dürer, esperienza speculativa del mondo: essere al di fuori di queste cose che restano là, distaccate, assolute e svaniscono senza contatto con noi”, il nostro guardare attraverso il vetro del finestrino del treno è un vedere senza possedere, a distanza, che proprio per questa sua caratteristica è in grado di darci “il silenzio di queste cose messe a distanza, dietro il vetro, che, da lontano, fa parlare i nostri ricordi o trae dall’ombra i sogni dei nostri segreti”. Magari i ricordi di un luogo perso e desiderato, il sogno di raggiungerlo. “Il vetro e il binario creano dei pensatori e degli gnostici” e – potremmo facilmente aggiungere – dei sognatori. Nel suo essere “carcerario e navale […] il vagone ferroviario unisce il sogno e la tecnica. La dimensione ‘speculativa’ riemerge così nel cuore del macchinismo”. Come ogni sognare vive nello scacco del risveglio, così il viaggio quello dell’arrivo: “E come sempre, bisogna anche uscire: ci sono soltanto paradisi perduti”, un po’ come per il nostro compagno di viaggio Carter. Pensatori, gnostici o sognatori obbligatoriamente si “torna a servire nel luogo predestinato”, “ricomincia il corpo a corpo con una realtà che schiaccia lo spettatore, privato di binari e finestrini”, “mentre un elegante gatto nero si alza […] sbadigliando dal sonno del focolare che il sobbalzo e il grido del suo padrone avevano disturbato”…
Cercavamo un talamo
al nostro bisogno.
Ci svegliammo. L’amore
rimase nel sogno.