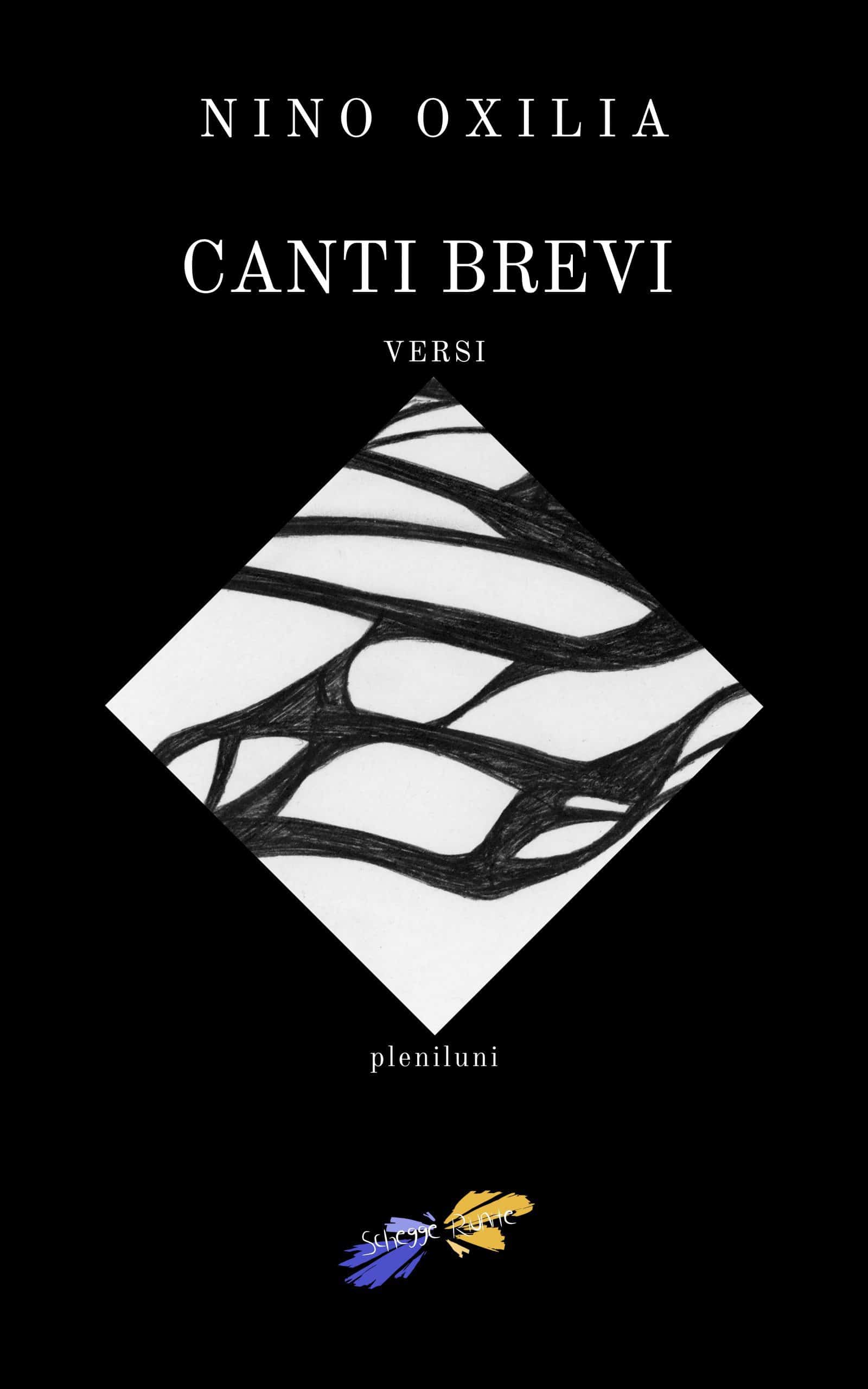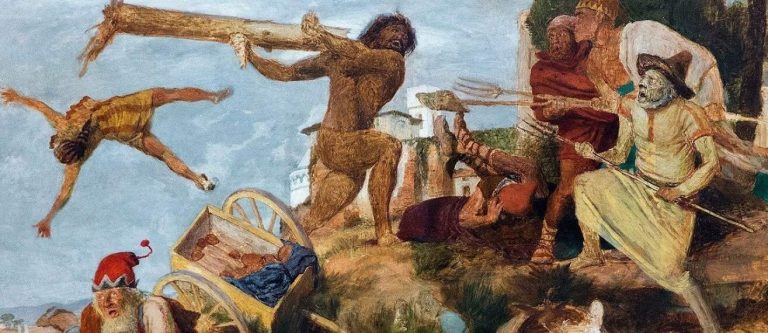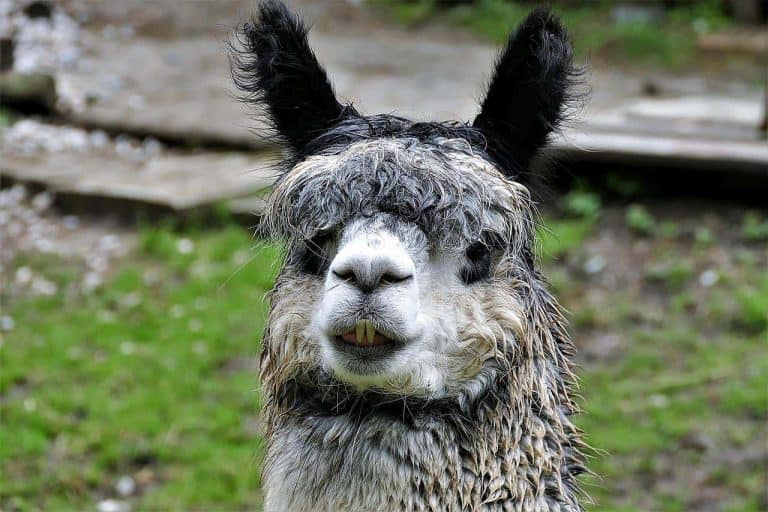Per le edizioni Schegge Riunite esce una nuova edizione dei Canti brevi – Versi -, del poeta piemontese Nino Oxilia. Nei primi del Novecento egli, oltre che poeta, fu drammaturgo, giornalista e ancor più fama raggiunse con la regia di mirabili pellicole quali Rapsodia satanica o Sangue Bleu. Film dove recitavano alcune tra le più affermate dive dell’epoca: Lyda Borelli, Francesca Bertini, e Maria Jacobini, amata del nostro poeta. Le liriche della raccolta, così ben radicate nello spirito della poesia crepuscolare del tempo, sono anche uno squarcio nel sentimento e nelle idee di Oxilia.
Convinti che l’unica maniera per poterle apprezzare sia leggerle, magari ad alta voce come richiederebbe la poesia, vi anticipiamo parte della prefazione.
Di Oxilia, o del non conoscere
Di cosa necessita una persona per essere lieta? Oxilia non lo sa. O se lo sa non lo dimostra e non ce lo fa conoscere nelle sue opere. Si potrebbe dire che forse è al nostro stesso livello, ma poi se venisse fuori che qualcuno conosce quel modo per esser lieto allora non sarebbe sul piano di Oxilia e di molti altri. Egli conosce il riso, di questo conosce e ne parla. Si vedano alcuni versi della poesia numero otto della seconda parte:
E ridere di voi, del mondo, della fede,
della speranza, ridere.
Oppure, più avanti nella quarta parte alla quinta lirica:
Folle è il pensare. In questo breve esilio
cui siam costretti impera la menzogna.
Non v’è amor, né speranza. Padre e figlio
mentono tutti. Ridere bisogna! […]
[…] agire in mezzo a queste umane cose
per noi, solo per noi, godere e odiare,
poi giungere alla verità: morire.
Questo riso sulla speranza, sulla cose che spesso muovono la vita delle persone non è dissimile dal riso di Democrito raccontatoci da Ippocrate, uno pseudo Ippocrate per la verità. Nelle sue lettere riporta: «[Democrito] rispose: “Tu [Ippocrate] attribuisci due cause al mio riso, i beni e i mali; ma io rido di un unico oggetto, l’uomo pieno d’insensatezza, vuoto di opere rette, puerile in tutti i suoi progetti, che sopporta senza alcun beneficio prove senza fine, spinto dai suoi desideri smodati ad avventurarsi fino ai confini della terra e delle sue immense cavità, fondendo l’argento e l’oro, non smettendo mai di accumularne, affannandosi sempre per possederne di più allo scopo di non decadere”.»[1]
Uno scopo, come appena letto in Oxilia, folle in quanto sempre alla morte si giunge.
In questa breve nota introduttiva, che ha al massimo l’ambizione di non far allontanare dalla poesia di Oxilia il lettore, si cerca solo di dar dimostrazione di come questi versi, anche rimanendo su un piano impressionista e per nulla approfondito o di studio, portino la mente e l’animo del lettore a confrontarsi con la propria natura di uomo nello sguardo di chi ha vissuto, e riportato su carta, la vasta caleidoscopia dei sentimenti senza giungere alla lietezza di cui si scriveva in apertura. È forse una breve raccolta di come si possa vivere, o si tenti di farlo, quando di sé si arriva a dire:
Io sono il figlio dell’ombra perfida,
dentro al mio cuore sento pozzanghere
bieche stagnare.
Tutta la grande ombra dei secoli
su di me pesa, che si contendono
Caino e Bruto.
Aborro il riso, ghigno alle lagrime,
disdegno i popoli, disprezzo i Cesari
non credo in Dio.
In questa carrellata di angosce tipiche dell’uomo moderno, di cui Oxilia si fa cantore, rimane nella chiosa panica, così propria del Crepuscolarismo, una piccola àncora di sopravvivenza:
A te soltanto, alba, che ascendere
sai e il cielo di sangue tingere
il cuor s’inchina.
[1] Ippocrate, Sul riso e la follia, Sellerio, Palermo, 1999, pp. 63-64.