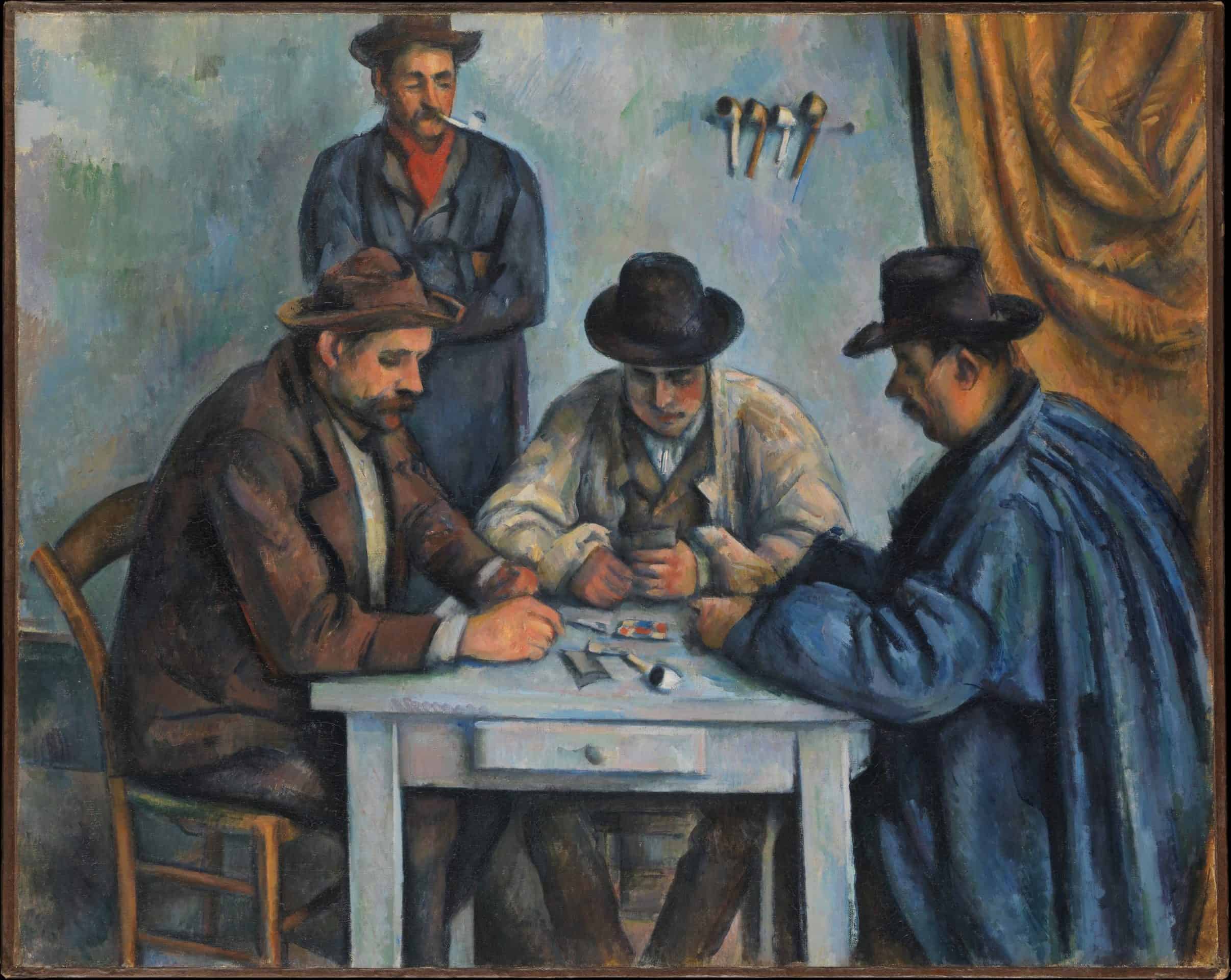Uno dei luoghi comuni maggiormente ripetuti riguarda il numero di figli per famiglia nel passato. Quanto possiede di vero? Davvero un tempo si facevano figli a oltranza, sapendo che ne sarebbero sopravvissuti la metà?
Le origini di un mito: la famiglia allargata
Innanzi tutto bisogna dire che questo luogo comune non è una semplice diceria; le famiglie numerose sono esistite ed esistono non poche prove, tra cui parecchie fotografiche, che testimoniano la presenza di tali realtà. Ascoltando i racconti dei propri parenti, soprattutto se originari dell’Italia meridionale e di estrazione contadina, una famiglia con una decina di figli, se non di più, prima o poi salta fuori, e questo è innegabile.
D’altra parte sia il sistema economico del latifondo che quello mezzadrile incoraggiavano non poco la formazione di unità economiche numerose, unità che erano tanto più forti quanto più forte era il legame al loro interno. Essendo il sangue un legame fortissimo, la famiglia patriarcale allargata era ampiamente diffusa in campagna, in quanto permetteva di avere molti lavoratori volonterosi ad un costo molto inferiore che se fossero stati assunti come manodopera.
La famiglia in Europa nell’età moderna
Da questo punto in poi occorrerà però iniziare a porre dei punti di discrimine e a descrivere le cose come stavano realmente. Innanzi tutto la famiglia numerosa è un fenomeno molto ristretto a livello spaziale. Avere molti figli fu tutt’altro che una moda in tutta Europa, a parte nella zona più meridionale e mediterranea, ovvero Italia, Spagna e Grecia. D’altra parte anche in Italia si possono osservare delle notevoli differenze tra Nord e Sud, differenze che si riflettono e nei diversi sistemi economici, e nei diversi costumi. La tendenza in tutta Europa nell’età moderna era di sposarsi parecchio tardi (dopo i 25 anni per gli uomini, dopo i 23 per le donne) e dunque di avere un numero limitato di figli, partorendone circa 5 per donna ammogliata, dei quali, per la nota incidenza della mortalità infantile e minorile, riuscivano ad arrivare all’età adulta solo 3.
Per chi non è digiuno di letteratura non sarà poi così sorprendente sentire questa notizia. Tristram Shandy è figlio unico e si presenta lui stesso come frutto dell’incauto accoppiamento dei suoi genitori fuori dal momento opportuno. Se le sorelle Bennet in Orgoglio e Pregiudizio sono ben cinque, questo non è certo un fatto ordinario ed è accettabile in quanto appartengono ad una prospera famiglia della borghesia di campagna. In Walter Scott e in Stevenson le famiglie, sia nobili che popolane, si aggirano sempre sull’ uno o due figli e non si può dire diversamente di Defoe e Fielding. Tutto ciò non deve particolarmente sorprendere: bisogna ricordare che la maggiore età restò a lungo a ventun anni e che per imbastire una famiglia occorreva prima di tutto poterla sostenere economicamente, mantenendo anche un livello di vita decoroso. Quest’ultimo fatto spiega, tralaltro, l’unicum costituito dalla società occidentale nel suo possedere un buon quinto della popolazione che rimaneva celibe.
La famiglia nell’Europa meridionale
In questo scenario, come già detto, l’Italia e gli altri paesi mediterranei costituiscono delle piccole eccezioni. Resta però da capire in che misura-
Innanzi tutto occorre fare un primo distinguo: la famiglia urbana resta molto più ridotta di dimensioni di quella contadina, sia in verticale che in orizzontale. L’urbanizzazione non ha ancora prodotto la scarsità di abitazioni che costringerà ad allargare la famiglia nel XX secolo, ergo essa resta semi-nucleare, includendo spesso uno o entrambi i genitori di uno dei due sposi.
In campagna invece si hanno, come è già detto, delle condizioni economiche molto particolari. Il passaggio dall’economia di villaggio a quella mezzadrile ha costretto a rimodulare la divisione della terra. I proprietari l’affidano a famiglie di contadini, i quali devono versare come affitto la metà di quanto producono. La terra non manca, quello che manca è spesso la manodopera per renderla il più possibile produttiva. Risulta quindi necessario allargare la famiglia sia in verticale che in orizzontale. Questo vuol dire che le unità economiche e abitative si gonfiano a dismisura rispetto a quanto non lo fossero in precedenza (ricordiamo che il Medioevo aveva favorito realtà nucleari) ma sempre fino a raggiungere un certo limite. Qual è questo limite? Esso è scandito dal succedersi delle tre generazioni che vanno a comporre la famiglia colonica. La terra è tanta, ma ha un limite, ergo può mantenere solo un numero limitato di persone. C’è bisogno di figli giovani e in forza che mandino avanti la baracca, ma non possono essere troppi, o non si campa. Una donna poteva trovarsi a partorire molte più volte (spesso sette o più) ma il numero di figli che arriverà all’età adulta non supera i cinque se non molto di rado. Quando la famiglia diventava troppo numerosa, uno dei nuclei era costretto ad allontanarsi e cercare un podere sfitto su cui lavorare a sua volta e costituire una nuova famiglia colonica.
In questo sistema in generale si tende a sposarsi alcuni anni prima; le certezze economiche nel mondo della mezzadria e del latifondo sono costituite dalla possibilità di avere un ricambio continuo di lavoratori in forze, il tetto c’è, il cibo ai contadini manca sempre per ultimo. Anche qui è spesso necessario che il più giovane dei figli resti scapolo o vada a cercar fortuna altrove, per limitare una crescita eccessiva della famiglia colonica.
Alcuni problemi matematici
Ora stacchiamo un attimo dalla storia, prima di andare a scoprire dove il mito si è originato e facciamo alcuni calcoli. Se questa sezione non interessa si può tranquillamente saltare a quella successiva, l’autore non se ne avrà a male.
Innanzitutto bisogna notare un fatto: avere un parente appartenente ad una famiglia numerosa è quanto più probabile quanto è più numerosa la famiglia d’origine. Se facciamo un rapido calcolo, Se A e B hanno due figli e C e D ne hanno 10, occorrono ben 5 famiglie AB perché la probabilità di incontrare un loro discendente sia paragonabile a quella di un CD. Se la cosa prosegue appena per un’ulteriore generazione, ce ne vogliono 25 e così via seguendo le rispettive potenze. Questo ci dimostra in maniera molto semplice che basta un numero ridotto di famiglie numerose per permettere di entrare in contatto con uno dei loro discendenti. Ergo, se le famiglie numerose fossero state un’altissima percentuale nelle famiglie in una certa zona, sarebbe sostanzialmente impossibile non discenderci tutti in qualche modo, considerato che dovremmo calcolare una media di almeno dodici generazioni solo per l’età moderna, il che, sorprendentemente, non è vero.
Ancora di più però potrebbe risultare interessante calcolare l’incremento della popolazione. Se dovessimo partire dal vecchio luogo comune dei dieci figli (senza introdurre alcuna altra variabile) ci troveremmo con famiglie che producono generazioni cinque volte la loro. Seguendo la progressione esponenziale ci ritroveremmo che in dodici generazioni una sola famiglia avrebbe prodotto 5^12 famiglie nucleari (244140625) ovvero oltre 488 miliardi di discendenti, circa sessanta volte la popolazione mondiale attuale.
Se iniziamo a introdurre il 20% di scapoli, la singola famiglia avrebbe prodotto appena 4^12 ulteriori famiglie (16777216) ovvero circa 33 milioni di discendenti. Per quanto riduciamo la base, immaginando che i figli prendessero strade diverse o finissero vittime di guerre, epidemie, carestie ci ritroviamo sempre con numeri colossali: oltre 500000 famiglie se la progressione fosse stata di triplicare il nucleo originario, più di 4000 se semplicemente fosse stato duplicato (e qua stiamo arrivando a immaginare una media di quattro figli per famiglia, numero molto vicino a quello del resto d’Europa).
Ora risulta evidente che in Europa settentrionale come in Europa meridionale la progressione della popolazione è stata molto più limitata e ha seguito un andamento tendenzialmente lineare almeno fino al 1900. Dati i piccoli giochi matematici che abbiamo appena effettuato, tutto questo non sarebbe stato possibile se il numero di famiglie dalla prole molto numerosa non fosse stato piuttosto limitato, come d’altra parte ci testimonia la diversa densità demografica delle campagne e delle città.
Eppure, è evidente che i racconti dei nostri parenti sui nostri avi sono un fatto. Come è possibile fare quadrare questi dati con gli altri, altrettanto oggettivi che abbiamo portato?
La rottura di un equilibrio e una transizione
La risposta, come spesso accade, è sotto gli occhi di tutti, anche se una certa mentalità progressista cerca in ogni modo di velare. La mitologizzazione basata sul progresso tende a dividere il tempo in un prima e un dopo rispetto ad un certo momento, quello appunto in cui il progresso ha avuto inizio. Da qui la creazione del mito negativo medievale, ad esempio, quando, in molti campi, si è proceduti avanti e indietro non in modo lineare, ma semplicemente a seconda delle opinioni del secolo.
Non è difficile, una volta rotta l’idea del fatto che prima fosse tutto uguale, immaginare un momento in cui le cose sono andate come ci testimoniano foto e parenti. E la storia ci conferma tutto questo.
Per quanto assurdo possa sembrare, ad aumentare a dismisura il numero di figli non fu l’arretratezza, ma il progresso tra XIX e XX secolo. Il primo passo fu l’introduzione di nuove tecniche e la meccanizzazione dell’agricoltura (e del settore primario in generale). Questo aumentò enormemente la produttività, riducendo allo stesso tempo il lavoro necessario a produrre. I contadini si ritrovarono con molto più cibo e quindi a assumere molte più calorie e nutrienti.
Dall’altra parte la più grande rivoluzione fu quella sanitaria. Nel tardo ottocento, dopo tre secoli dalla sua prima formulazione, la teoria dell’origine microbiologica delle malattie prese il sopravvento. Molte malattie ed epidemie che in precedenza erano incurabili e uccidevano o lasciavano pesantemente menomate le loro vittime iniziarono a trovare vaccini e cure adeguate. Vi fu poi la cosiddetta rivoluzione igienista che portò da una parte ad una notevole riforma dell’igiene urbano, dall’altra ad un forte potenziamento degli standard igienici (ricordiamo che l’età moderna ebbe fino ad allora una forte avversione all’acqua).
L’insieme di tutti questi fattori portò ad una maggiore salute degli individui, aumentandone la fertilità. Dall’altra parte anche la mortalità infantile subì un brusco calo (avrebbe avuto ancora qualche picco durante le guerre) sempre per ragioni igieniche e non, una delle quali fu la reintroduzione dell’allattamento al seno. I figli dunque avevano più probabilità di nascere e più probabilità di vivere.
Ora, ogni società di ogni tempo tende a costruire la sua cultura per favorire la propria prosperità morale e materiale. Le società tradizionali sono basate su un’armonia di equilibri estremamente complessa e raffinata. Esse hanno dei rimedi culturali ai problemi che la società stessa può trovarsi ad affrontare, ma nel caso di un forte cambio di scenario, dell’introduzione di nuovi fattori, spesso si trovano disarmate.
In questo caso l’insieme di tutti questi nuovi fattori provocò un grande cambiamento improvviso delle condizioni di vita cui la cultura non era minimamente preparata. Il numero di figli e di rapporti fertili considerato appropriato era basato su fattori totalmente diversi e d’altra parte il cambiamento era inaspettato. Va tenuto poi conto che la cultura positivista che iniziava a diffondersi instillava una fiducia cieca nel progresso e nella scienza, che avrebbero presto risolto ogni problema.
Nessuna società sarebbe potuta uscire intatta da uno choc del genere e così fu per la nostra. La serie colossale di squilibri portò alla creazione di un nuovo tipo di società in cui era necessaria un’azione molto più forte delle istituzioni nella vita privata, per creare, tra le altre cose, una nuova cultura che permettesse di reagire ai nuovi tempi. Il cambiamento richiese decine e decine di anni (in alcune cose al momento siamo ancora privi di equilibrio) lasciando indietro e più vulnerabili le categorie meno tutelate, ovvero le grandi famiglie contadine delle zone più periferiche che dunque proseguirono con le usanze che avevano in precedenza.
In questo modo si venne a creare una realtà paradossalmente nuova perché basata su modalità antiche. Allo stesso tempo però le modalità del passato non avevano anticorpi, né rimedi per gestire delle famiglie così grandi, ergo esse si ritrovavano in una situazione di forte stress e a volte anche alienazione in quello che dovrebbe essere il luogo più accogliente; ed ecco che il terrore della famiglia numerosa trova il suo sito e la sua motivazione.
Va notato infine che questo avvenne soprattutto in zone molto lontane dalla città e dunque molto periferiche rispetto alla diffusione dei “rimedi”, che ebbero un forte impatto positivo. Anche solo il rimescolamento con altri strati della popolazione che avveniva nelle zone più prossime alla città permetteva di avere dei modelli di famiglia decisamente più sostenibili che venivano difatti attuati con molta più coerenza.
Bibliografia
Austen, Jane, Orgoglio e Pregiudizio
Barbagli, Marzio, Storia della famiglia in Europa
Sergi, Giuseppe, Bordone, Renato, Dieci secoli di Medioevo
Sterne, Laurence, Vita e opinioni di Tristram Shandy
Samuele Baracani: nato nel 1991, biellese, ma non abbastanza, pendolare cronico, cresciuto nelle peggiori scuole che mi hanno avviato alla letteratura e, di lì, allo scrivere, che è uno dei miei modi preferiti per perdere tempo e farlo perdere a chi mi legge. Mi diletto nella prosa e nella poesia sull'esempio degli autori che più amo, da Tasso a David Foster Wallace. Su ispirazione chauceriana ho raccolto un paio di raccontini di bassa lega in un libro che ho intitolato Novelle Pendolari e, non contento, ho deciso di ripetere lo scempio con Fuga dai Faggi Silenziosi.