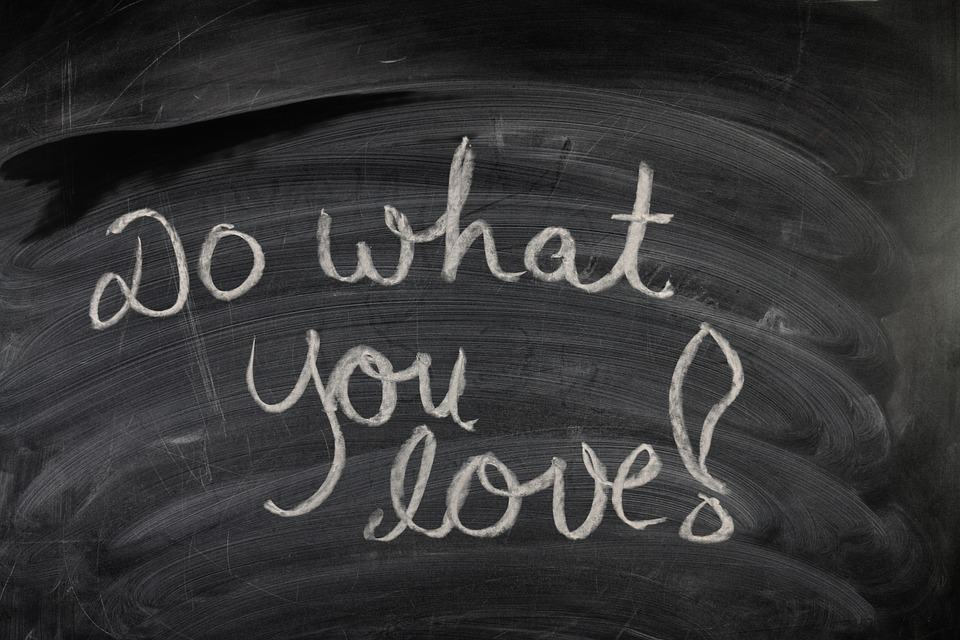Le malattie che sconvolgono l’accademia moderna, sia nei campi scientifici che in quelli umanistici e tecnici, sono numerose, ma si possono ricondurre ad un solo grande problema, ovvero l’ansia di campare del proprio studio. A riguardo si trova un interessantissimo articolo di Storia delle Idee che vi invito a leggere.
Il pezzo si occupa principalmente di articoli-truffa, e dell’ansia di dover pubblicare e presto e ad ogni costo. Sulla pagina facebook del sito e su Il chimico scettico si trovano altri contributi che aiutano a completare il quadro, se non per un piccolo dettaglio che già abbiamo trattato. Noi italiani siamo abituati a concepire la ricerca come un fatto puramente statale, in cui per lo più un’Università pubblica riceve una borsa di ricerca pubblica per portare avanti uno studio su un qualche argomento. Questo sistema ha dei pregi e dei difetti che tutti conosciamo bene, perché crea una competizione viziata un poco da baronie e favoritismi, ma allo stesso tempo non costringe chi vuole dedicarsi allo studio di dover fare salti mortali per convincere un eventuale investitore a concedergli la sua fiducia.
Il mondo però è grande e vario e le situazioni spesso sono molto più complicate nell’accademia sia estera che qui da noi, perché ovviamente il mondo accademico non si basa solo sull’accademia stessa. Attorno al mondo della ricerca ruota un’enorme quantità di realtà parallele che ci orbitano attorno e lo condizionano. Conferenze, convegni, circoli letterari e culturali, editoria, televisione e infine il web hanno un peso enorme sui ricercatori e i professori, ed esercitano un fascino spesso estremamente pericoloso. Per come si è andata strutturando, l’accademia si è costituita come un’immenso sistema in cui tutti controllano tutti; questo fa sì che il singolo studioso per poter affermare qualcosa debba prima avere un buon numero di argomenti per sostenerla, a meno che non desideri essere sbranato dai suoi colleghi, che ovviamente avrebbero solo da guadagnare dal pubblicargli qualcosa contro. In questi altri contesti invece è molto difficile che si formi un vero dibattito scientifico; fuori dal mondo della ricerca, lo studioso e il professore sono delle autorità e molto difficilmente dovranno confrontarsi con un contraddittorio alla pari. Questo dà adito ad una terribile tentazione al più onesto dei professori; una piccola iperbole non farà certo male a nessuno. Chi lo sa, magari basta esagerare un pochino l’importanza di una scoperta per regalare ad una disciplina trascurata e a tutti i colleghi che ci lavorano un pochino di visibilità e magari qualche finanziamento a quei colleghi che stanno mezzo morendo di fame; oppure potrebbe fornire l’occasione di pubblicare per altra via quello studio un po’ controverso che la rivista scientifica di turno non gli ha voluto accettare; o magari ancora potrebbe essere una fortuna per quel libriccino che ha pubblicato a riguardo, sperando di arrotondare un pochino sullo stipendio, e che invece sta andando malissimo; magari invece è il luogo o il momento di buttare in gioco quell’opinione indimostrabile di cui però si è profondamente convinti, o anche solo di ottenere la piccola soddisfazione della fama, che nell’accademia è così rara quanto qualsiasi altra soddisfazione.
In ogni caso quello in quel contesto non vigono le regole solite e probabilmente il ricercatore è convinto che questo gli permetta di fare delle affermazioni azzardate non solo senza conseguenze, ma anche senza intaccare il lavoro dei suoi colleghi. Di fesserie tra libri, giornali e televisione se ne sentono tante, su internet ancora di più, e il mondo della ricerca giustamente se ne infischia e va avanti per la sua strada. Si tratta di tentazioni a cui è facile cedere, come già ci ricorda il caso di Galileo, ma che hanno delle conseguenze pesanti. Il coperchio che il diavolo si dimentica di fare è costituito dal fatto che l’accademia non è impermeabile al resto del mondo. Il nostro panorama mentale è costituito non solo da quello che studiamo, ma anche da quello che ci circonda e permea la nostra cultura; ma anche se tutti gli accademici fossero immuni alla mentalità comune, non così lo saranno quelli che ancora accademici non sono. Le menti del domani sono forgiate nell’oggi e si abbeverano ai pregiudizi e agli errori che sentono nella loro vita quotidiana. Rimuovere loro queste convinzioni dopo che si sono radicate profondamente nella mente di una persona è alle volte un compito troppo arduo persino per l’Università. Lo studioso dell’oggi però non se ne cura; per lui è molto preferibile un bel salto dal pinnacolo del Tempio, piuttosto che restare nell’anonimato dell’accademia. D’altra parte, se facesse diversamente, non sarebbe di certo invitato: il pubblico vuole lo spettacolo, non una noiosa lezione.
Ed è così che nasce e cresce quell’infinita processione di galletti e truzzi coronati di titoli accademici che ci ritroviamo continuamente su ogni tipo di media a sponsorizzare ciascuno la propria più o meno strampalata teoria. Gente che si ritrova lì a vantarsi della propria scoperta straordinaria sulla Bibbia o sull’Iliade, o ancora sulla Divina Commedia. Tamarri che vanno in giro a flettere i muscoli mentali per fare colpo, sostanzialmente prostituendo tutto quello che hanno mai studiato e imparato veramente. Le regole dei mezzi di comunicazione sono semplici: o l’accademia diventa avvincente, o non ha spazio. E il bello è che l’accademia è spesso avvincente per chi la vede dall’interno; esistono davvero moltissime ricerche che alla lunga possono essere rivoluzionarie per gli addetti ai lavori, e altre che aggiungono particolari importantissimi e molto interessanti per coloro che se ne occupano. L’unico problema è che non lo saranno mai nel modo in cui ai media piace. Non saranno mai colpi di scena che cambiano il mondo, ma al massimo lente transizioni fiorite da centinaia di discussioni e dibattiti che lentamente indirizzeranno la conoscenza nella direzione giusta.
Basti pensare a con quale fatica il Medio Evo si stia liberando della nomea di epoca oscura in cui nessuno si lavava e la popolazione era ridotta in schiavitù, nonostante ci siano studiosi affermati anche in televisione che cercano di smontarne la leggenda nera. D’altra parte è più facile ricordare Barbero che ripete spranga a ritmo di musica, che tutte quelle piccole cose un po’ scomode che ci costringerebbero a mettere in discussione almeno alcune delle nostre idee.
E d’altra parte è molto difficile poter parlare con qualsiasi altra persona che è stata nutrita con queste idee, così ne risulta che l’unico modo per l’accademia per arrivare alle persone comuni sia quello di sottomettersi alle regole della comunicazione, a inseguire lo spettacolare, e a tradirsi in nome della sua stessa sopravvivenza. Così, ogni nuovo studio diventa una rivoluzione, una notizia shock, che poi resta senza conseguenze, dato che spesso di scioccante c’è solo la patina glitterata che ci viene spalmata sopra a piene mani. E qui si vede il rischio ultimo che si corre a causa di questa tendenza, che va ad assommarsi a quelli precedenti.
Lo studio non è solo appassionante, è principalmente costituito da sacrificio e fatica; una rivoluzione, che sia scientifica o meno, si fa col sudore e col sangue, col sacrificio dei quelli che ci si sono dedicati. L’accademia non è tanto un luogo noioso, ma uno che vive la sua lenta e dura guerra contro l’ignoranza non seguendo i guizzi carichi di effetti speciali di un documentario fatto per attirare l’occhio, ma nelle trincee quotidiane delle biblioteche, dove si conquista l’onore solo dopo la fine di tutto, non di certo affrontando uno contro tutti il mondo intero. Chi si lancia in quest’avventura, anche solo iscrivendosi all’università, sa che le cose stanno così? Cerca un posto nella Hall of Fame, una posizione da cui guardare gli altri dall’alto in basso, si autoinganna sull’importanza di quello che sta facendo, oppure è sinceramente pronta alle sferzate dei colleghi e della sorte? E ancora, se l’accademia è diventata un luogo di questo tipo, non si formerà una corsa insensata alla prima pagina fra le varie ricerche, allo stesso tempo forzando estremamente la competizione, che già è selvaggia, tra i ricercatori? E dato che sono le ricerche da copertina quelle che vengono premiate, che ne sarà di tante altre, magari meno vendibili, ma che possono costituire i mattoni ordinari di una ricerca molto più grande?
Per queste ragioni occorre sempre di più despettacolarizzare l’accademia, renderla di nuovo ordinaria, sia pure rinunciando a qualche minuto di gloria e a qualche milione di spettatori. Quello di cui il mondo ha bisogno non sono i lustrini, ma basi solide su cui umilmente costruire.
NB: Il conio accademia tamarra è di Paolo Ghiglione, linguista, esperantista, pianista, che ho la fortuna di conoscere personalmente.
Samuele Baracani: nato nel 1991, biellese, ma non abbastanza, pendolare cronico, cresciuto nelle peggiori scuole che mi hanno avviato alla letteratura e, di lì, allo scrivere, che è uno dei miei modi preferiti per perdere tempo e farlo perdere a chi mi legge. Mi diletto nella prosa e nella poesia sull'esempio degli autori che più amo, da Tasso a David Foster Wallace. Su ispirazione chauceriana ho raccolto un paio di raccontini di bassa lega in un libro che ho intitolato Novelle Pendolari e, non contento, ho deciso di ripetere lo scempio con Fuga dai Faggi Silenziosi.