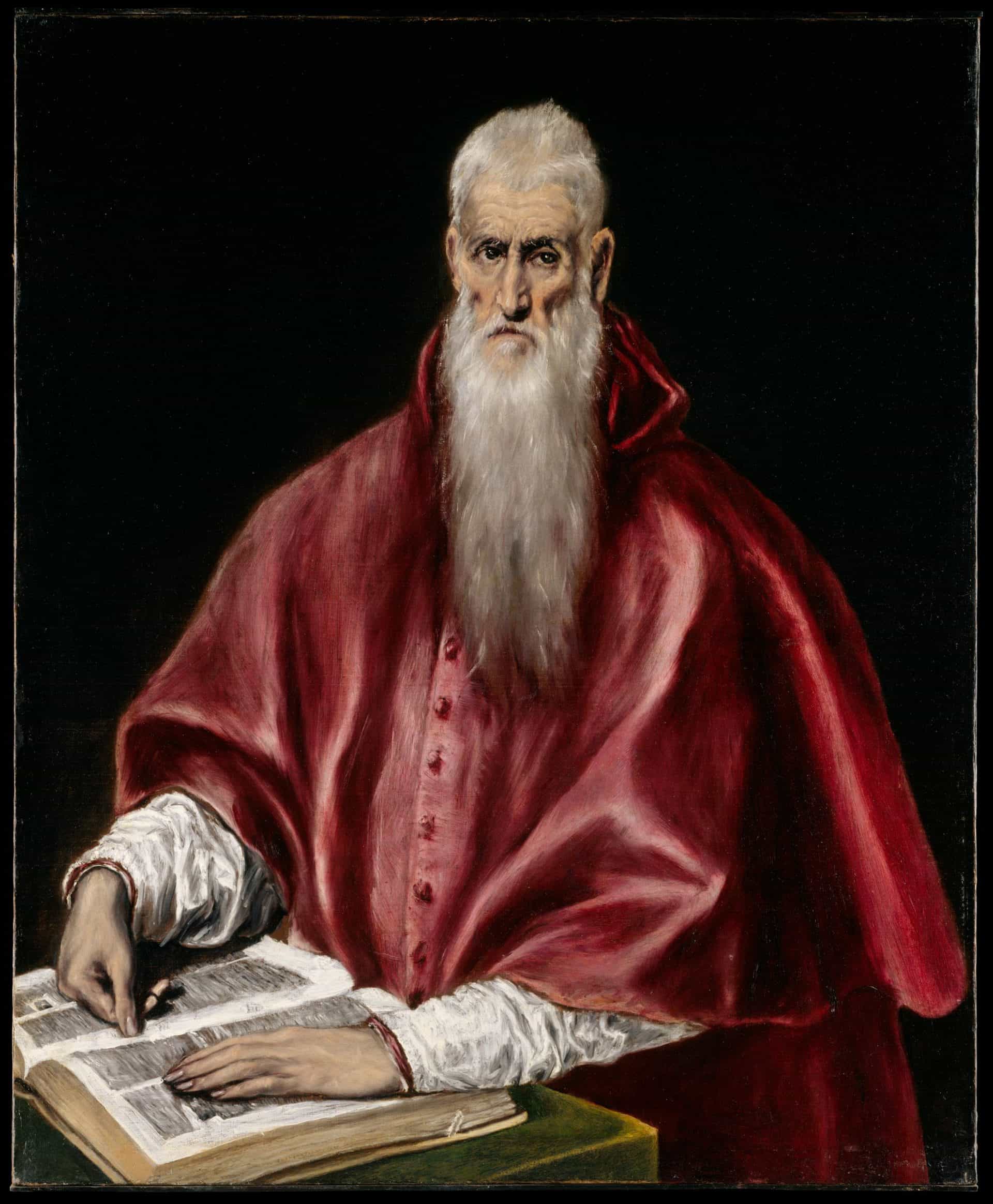Lo stato attuale delle lettere e delle arti liberali è decisamente poco promettente e, viste le prospettive, pare non possa che peggiorare. La letteratura è ridotta ad un relitto archeologico, bello ma che nulla ha a che fare con la modernità, la tecnica avanza, l’accademia si sta reindirizzando verso la scienza e lo spettacolo sta colonizzando il resto con i suoi lustrini che spesso nascondono il nulla. Quando si parla di nuovo umanesimo si finisce col parlare di una nuova antropologia, di una diversa concezione dell’uomo, spesso figlia della tecnica o della tecnologia, non di certo del costruire una cultura incentrata sull’uomo.
L’umanesimo si occupa dell’uomo
Sembra quasi che la rivoluzione copernicana iniziata da Boccaccio e portata a termine da Kant non potesse avere altra soluzione che affidarsi alle macchine, forse proprio perché l’uomo è diventato una macchina a sua volta. Di fondo il materialismo marxiano, poi declinato nelle sua varie forme, così come quello liberale, non si sono mai veramente distolti dall’uomo, cambiandone solamente la concezione. L’Umanesimo non ha mai avuto termine, da dopo la peste e si è solo riconfigurato a seconda delle varie antropologie che si è trovato costretto a produrre, dato che nessuna era veramente esaustiva. L’uomo moderno e contemporaneo si ritrova costretto costantemente a parlare di sé per il semplice fatto che non ha la minima idea di chi è. Fin da Hobbes si concepisce come una serie di meccanismi, e fin da Hobbes non può che riconoscere che ha un estremo bisogno di un qualcosa di esterno per sorreggersi.
L’individualismo soggettivistico cartesiano non si basta. Pensare di essere fatti di pensiero resta una piacevole tautologia con ben poche applicazioni pratiche, anche se apre la via ad infinite teorie. La vita degli uomini non è fatta di studio, neppure per quanto riguarda gli accademici più accaniti, figuriamoci per il resto del mondo. L’umanesimo fondato sul pensiero ha escluso dalla cultura la maggior parte della popolazione, finendo col parlare di cose sempre più vuote e astratte. Si può criticare quanto si vuole le discussioni della Scolastica, ma la cultura occidentale successiva non ha fatto molto di diverso. Può darsi che sia la consueta questione dell’esser figli del proprio contesto, ma tutto quello che è stato prodotto nel pensiero europeo è sostanzialmente teologia: si è semplicemente passati da una teologia che parlava di Dio ad una teologia dell’uomo, poi del pensiero, della scienza, fino ad arrivare alla teologia del nulla e dello stato.
L’occidentale, e forse questo vale anche per tutto il resto del mondo, non sa concepire la sua filosofia al di fuori della religione e dell’escatologia; sceglie semplicemente cosa venerare. L’umanesimo ha posto sull’altare l’uomo, senza riuscire a capirlo e ha tentato in ogni modo di spiegarlo passando da ogni tipo di spiegazione, dal materialismo al nichilismo, per finire col cascare nel socialismo. La crisi d’identità occidentale pone le sue radici in questo continuo cambiare paradigma che è il risultato di un ripiegarsi su sé stesso dell’uomo postmedievale. Il vantaggio del contadino medievale era che, se pure non capiva le complesse diatribe dei teologi, l’origine della sua identità gli era sempre a disposizione. Gli bastava entrare in una chiesa o anche solo contemplare la creazione, gli bastava pregare da solo per ricordarsi chi era. E sapeva che, teologo o non teologo, qualunque altro uomo sulla terra era fatto esattamente allo stesso modo. L’uomo moderno ha rifiutato questa risposta ed è andato in cerca di sé dentro di sé. Nonostante Eraclito avesse ammonito già da secoli e secoli sul fatto che non si possono trovare i confini dell’anima, l’umanesimo pretese di avere la risposta non tanto a chi, ma a che cosa fosse l’uomo, credendo di poterlo comprendere come l’insieme dei suoi attributi e non come il suo scopo. Se per il medioevo l’uomo era un potenziale beato, e la sua realizzazione stava nel raggiungere il Paradiso, per l’umanesimo divenne il suo ingegno, o i suoi sensi, o la sua capacità di conoscere e così via. Per assurdo, non si abbandonò per nulla l’idea di realizzazione, segno che forse l’uomo non può pensarsi senza uno scopo. Persino Nietzsche e Schopenhauer avranno la loro teologia ed escatologia nichilista e non potranno rinunciare a dire che cosa si deve fare per essere, se non realizzato, per lo meno meno infelice. Questa aporia resta insolubile, per una semplice ragione: il pensiero è sempre diretto ad uno scopo, il senso mosso da un obiettivo, l’azione da una ragione e verso un oggetto. Anche se meno visibile, il principio di finalità esiste anche negli animali e persino nelle piante; escluderlo dall’uomo è impossibile. E qui inizia a cascare l’asino.
Un fondamento sbagliato
Se l’umanesimo parla dell’uomo, basta un vecchio mezzo matto con un lanternino per metterlo in ridicolo. Se nei ventiquattro secoli abbondanti trascorsi da Platone ad oggi non siamo ancora riusciti a comporre un’antropologia coerente, ed anzi, più gli studi a riguardo si sono intensificati, più ci siamo trovati in una babele di pensieri diversi, contraddittori e ramificati, forse c’è una ragione. Possiamo inseguire quanto vogliamo una definizione onnicomprensiva dell’uomo senza mai raggiungerla. Poco importa se sia perché l’essere umano è infinito o meno, i nostri mezzi, come il lanternino di Diogene, non sono e non saranno mai sufficienti a illuminarlo tutto. Questo, oltre a distorcere e dar troppa importanza, allungandone le ombre, alla parte che stiamo prendendo in esame, finirà col produrre una letteratura specialistica che si pretende in qualche modo come definitiva e allo stesso tempo silenziosamente si discosta e disprezza le altre che fanno la stessa cosa, pochi passi più in là.
Doversi districare nel labirinto delle arti liberali moderne non potrà produrre alla lunga che stanchezza e noia. L’uomo, in fin dei conti è un argomento tanto vasto quanto poco interessante, almeno finché rimane teoria. Alla persona comune interessa al massimo sapere chi è lui, forse che cosa è lui, ma difficilmente cosa è il genere a cui appartiene. Sapere che siamo tutti uomini, tutti fratelli, che esiste l’umanità è quanto gli basta. Poi quello che gli importa è conoscere sé, la persona di cui è innamorato e quelle con cui ha a che fare per affetto o per necessità. Certo, non disdegnerà una nota o un suggerimento alla Wolfram Von Eschenbach, ma appunto perché lo aiuta sui suoi passi. Dover correre dietro a mille opinioni discordanti e imprecise è una fatica troppo grande per qualsiasi persona dotata di buon senso, persino se il premio fosse la felicità. La conseguenza è semplice: l’uomo è interessante quando non parla di sé, e lo stesso si può dire delle arti liberali. Un vero peccato che l’umanesimo abbia scelto di fare entrambe le cose.
L’umanesimo della tecnica
Non è un caso, visto questo panorama, che la tecnica avanzi. La macchina ha esattamente tutte le caratteristiche per avere una cultura di successo. I più specialisti sanno esattamente come è fatta e come funziona, tutti conoscono lo scopo per cui è stata fatta e cosa può fare. Ciò che le permette di vincere sulla cultura non è che sia più appagante, quanto piuttosto che abbia una metafisica e che questa non sia vaga.
La cultura può lamentarsi quanto vuole di stare morendo, ma il fatto è che non si tratta di una morte naturale, né di un omicidio. Si tratta del lento e narcisistico suicidio di chi vorrebbe ancora avere su di sé gli occhi di tutti. La cultura sta sempre di più affermando di essere inutile, anzi, se ne vanta, e tuttavia pretende di essere superiore alla tecnica. L’unico ruolo che si continua ad attribuire è quello di fornire una distinzione sociale e al massimo di fornire un supporto debole e cadente alla politica. La divulgazione ha divorato lo spazio che poteva avere nel parlare del mondo, e gli è stato tranquillamente permesso di farlo. Un umanista non poteva certo permettersi di scendere dalla sua torre d’avorio e parlare alla gente. Infilarsi nel fango, sporcarsi le mani e le vesti, sono cose da plebei, meglio rimanere a mani pulite e vuote e gloriarsi di quanto siano tali. Certo, un giullare o un poeta d’altri tempi poteva permettersi di usare la lingua e i modi della gente, ma uno dei nostri no di certo. Altrimenti dove andrebbe a finire il suo valore?
Ma se questo valore dipende solo dal riconoscimento di superiorità che gli viene attribuito, allora l’umanesimo è bello che estinto. Non può moltiplicarsi, non può produrre una cultura che sia condivisa, non può sbagliare e correggersi, o questa superiorità viene meno, non può far altro che abitare la prigione dorata che esso stesso si è costruito e rinchiudere con sé tutti quelli che gli hanno creduto. E purtroppo la letteratura è fra questi ultimi. Basti solo pensare a quanto è difficile parlare di letteratura contemporanea. L’unica cosa che si riesce a fare è ricadere nel purismo e ammirare i grandi del passato, magari anche recente, senza commentar troppo il valore di quelli che ora sono in lizza. E questo perché la medaglia di poeta e letterato è diventata troppo importante per poter essere meritata. Al massimo si può parlare di bravo scrittore, il che non distingue fra uno che sa narrare bene, uno che sa rigirare la frittata come gli pare, uno che ha qualcosa da dire e uno che ha solo una gran voglia di parlare o di accedere a questo status, anche questo una sorta di torre d’avorio a sé stante.
Alla fin fine l’umanesimo non è solo morto, forse proprio nella sua nascita, ma ha fatto e sta facendo di tutto per trascinare con sé anche le arti liberali, rinchiudendole nel proprio schema e impedendo loro di andare a fare ciò per cui sono nate.
Samuele Baracani: nato nel 1991, biellese, ma non abbastanza, pendolare cronico, cresciuto nelle peggiori scuole che mi hanno avviato alla letteratura e, di lì, allo scrivere, che è uno dei miei modi preferiti per perdere tempo e farlo perdere a chi mi legge. Mi diletto nella prosa e nella poesia sull'esempio degli autori che più amo, da Tasso a David Foster Wallace. Su ispirazione chauceriana ho raccolto un paio di raccontini di bassa lega in un libro che ho intitolato Novelle Pendolari e, non contento, ho deciso di ripetere lo scempio con Fuga dai Faggi Silenziosi.