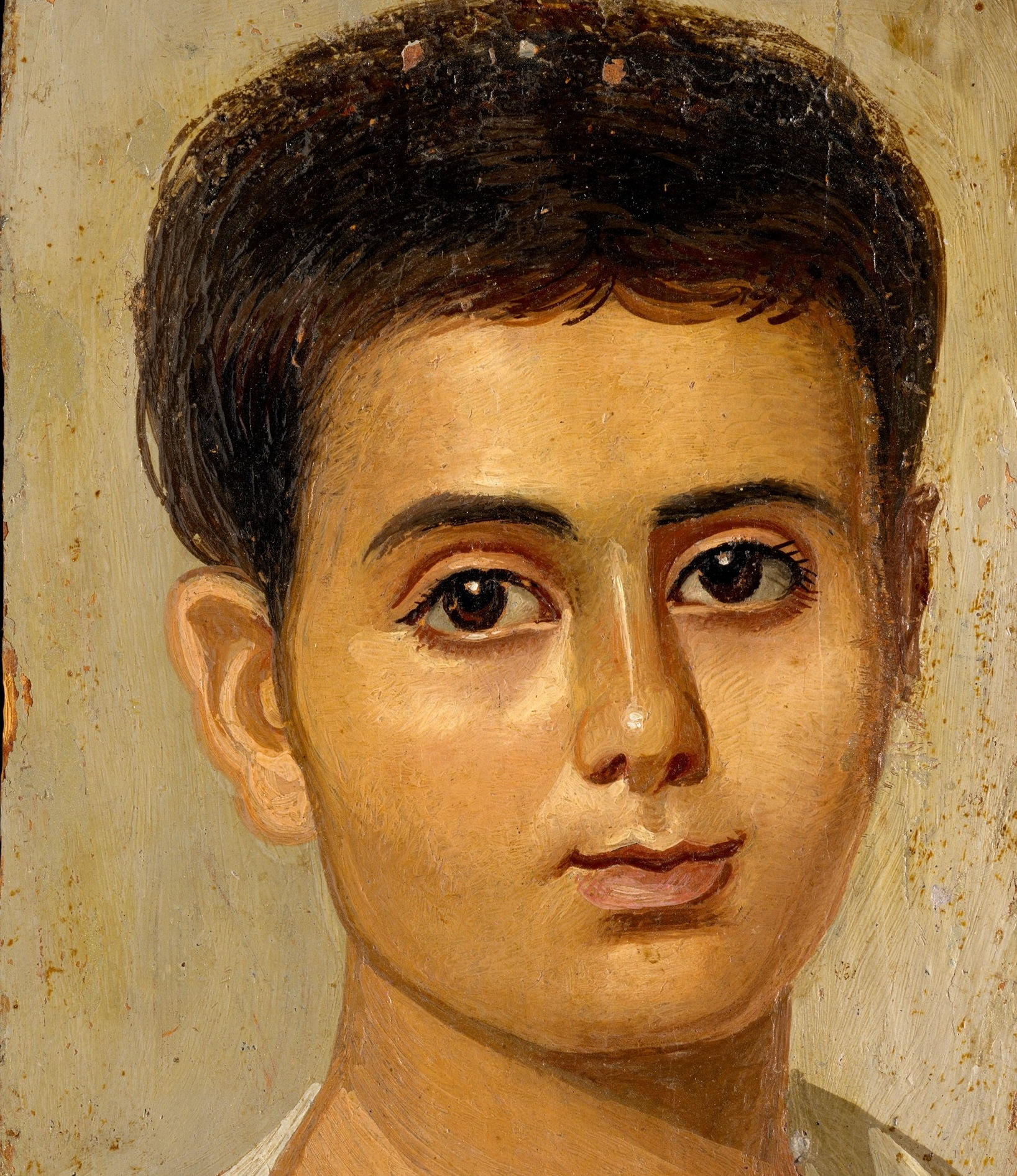Abbiamo trattato lo schiavo dell’epoca arcaica e quello della commedia greca e romana. Ora ci tocca occuparci di quello dell’epoca d’oro della letteratura latina, ovvero tra I secolo a.C. e I d.C.
Una piccola nota storica
Finora abbiamo analizzato la realtà della schiavitù in un mondo fatto di piccole aree circoscritte. L’espansione di Roma nell’età preclassica, per quanto rapida, seguì per lungo tempo metodi e modi che appartengono alla modalità della città-stato più che di un vasto impero. Quanto alla commedia greca è tutta di matrice ateniese e di conseguenza ne possiede i caratteri specifici.
Dal II a.C. però l’espansione di Roma già sta diventando esplosiva. Non è un caso che molti autori latini di questo periodo non siano affatto romani, ma greci “importati” dalla loro patria ed è ancora di meno un caso che la commedia latina sia la traduzione poetica della Neà greca.
Nel I secolo a.C. questa espansione continua e se ne iniziano a vedere gli effetti. Avere un grande impero a disposizione, regolato secondo le norme amministrative romane, vuol dire avere una grande fioritura di commercio e affini. Il mondo romano è cambiato rapidamente nel giro di centocinquant’anni e questo incide anche sulla figura dello schiavo.
In precedenza lo schiavo era principalmente un prigioniero di guerra o un uomo che si era venduto per debiti. A lui si affidavano lavori di fatica o il compito di occuparsi della casa. In questo periodo però la quantità di schiavi a disposizione è diventata enorme, sia frutto delle conquiste, che delle generazioni di nati non liberi, che si sono moltiplicate. I romani hanno una mentalità pratica e iniziano a selezionare i propri schiavi in base alle loro capacità, per utilizzarli in modo efficiente. Si creano le scuole gladiatorie, si mandano i più solidi nelle miniere e nelle cave, quelli abili col calamo vengono messi a produrre libri o a fare da segretari e e quelli abili coi numeri a fare da amministratori. Molti di questi servono così bene i loro padroni da venire liberati come premio per la loro capacità. Il liberto spesso continua a servire il proprio padrone, costandogli meno perché non deve essere mantenuto, e allo stesso tempo bada ai propri affari.
Lo schiavo
Lo schiavo inizia a godere di privilegi particolari, ma questo non vale per tutti. Lo schiavo di fatica e lo schiavo di piacere non smettono certo di esistere e la loro condizione non è particolarmente migliorata. L’influenza greca spinge i nobili romani a tenersi un puer per il loro piacere, come ci testimonia Orazio e d’altra parte in Petronio se ne trovano in gran quantità fin da principio.
Un’altra figura particolare è quella del gladiatore, di cui però ci converrà parlare più estesamente in seguito. Qui basti sapere che i gladiatori furono in grado di organizzare ben due grandi rivolte degli schiavi che misero seriamente in pericolo la sopravvivenza della Repubblica.
Nella prima parte dell’età classica il servo sembra però eclissarsi, se non per sporadiche comparsate, dalla letteratura. Forse proprio per la sua natura di attore in secondo piano nella storia, nella storiografia e nell’epica virgiliana non compare mai con ruoli rilevanti. Ancor meno poi nella poesia amorosa, dove al massimo può essere un tramite fra i due amanti. Può darsi che le rivolte degli schiavi abbiano tolto la voglia di fornire un mezzo per una coscienza di classe ad una casta sempre più numerosa e pericolosa, ma questo non ci è dato saperlo con precisione.
Con il consolidarsi del principato però le cose cambiano. Tiberio è molto diverso da Augusto e ha degli schiavi molto più versati di lui in ambito amministrativo. Anzi, è uno dei primi imperatori a dare molto spazio ai suoi liberti nell’amministrazione.
D’altra parte, si afferma lentamente nelle classi superiori una diversa cultura riguardo agli schiavi, probabilmente dovuta all’influenza stoica, che ne sottolinea sempre più l’umanità nonostante la condizione inferiore, come possiamo leggere abbondantemente in Seneca.
Il liberto
Il liberto è uno schiavo che, grazie ai suoi meriti, ha ottenuto la libertà. Guardato con sospetto dagli altri uomini liberi e soprattutto dagli aristocratici, si trova nella peggior posizione sociale possibile, quella del parvenu. Ha una mentalità pratica e borghese che gli ha permesso di avere successo, ma non è un tempo in cui questa può essere apprezzata. I nuovi ricchi sono visti come un pericolo e sono un bersaglio d’invidia da parte sia dell’aristocrazia che della plebe romana.
Allo stesso tempo però il liberto non può che avere successo. Sa lavorare e ha tutte le conoscenze e gli agganci adatti a riuscire nel suo ambito, senza contare che spesso ha incarichi in ambito amministrativo, fino a governare lo stato, come si dice avvenne sotto Claudio. Solo gli occorre qualche generazione per reinserirsi nella società, che d’altra parte, con i numerosi cambiamenti che stanno avvenendo sta cominciando a fratturarsi e frammentarsi.
Petronio nel Satyricon ne fa un ben poco lusinghiero ritratto, partendo proprio dal banchetto di un liberto, pieno di pacchianerie esagerate per dimostrare la propria potenza economica e sociale. Trimalcione stesso è rappresentato come l’apice della corruzione dei costumi romani, troppo decadente persino per l’autore stesso. Nella letteratura di corte quindi il liberto viene visto come prodotto indecente di un tempo degenere, forse concausa della degenerazione stessa, come ci conferma Svetonio. Dire quanto di tutto questo è motivato da invidia e frammentazione sociale è difficile, ma un piccolo esempio di altro genere ci può aiutare a gettare per lo meno un po’ di virtù su questa figura.
Fedro
Come lo schiavo agli inizi della letteratura latina, il liberto non è un semplice subalterno ignorante, e può diventare un autore importante. Il pubblico a cui si rivolge però non è lo stesso della commedia latina. Roma è diventata immensamente più grande e variegata non solo nella sua composizione censitaria, ma anche in quella etnica e culturale.
Se agli albori l’Urbe era totalmente priva di una letteratura di livello, e doveva dunque importarla, ora ne possiede una ben più poderosa ed originale, o inserita nel dibattito culturale coevp, destinata ad accrescersi come non mai fino ad offuscare i fasti precedenti. Questa letteratura è particolarmente promossa dal mecenatismo augusteo, e di conseguenza riflette principalmente gli interessi della classe dirigente e della sua propaganda. Questo permette ad un’altra forma letteraria più umile di venir ripescata da un liberto di origine Macedone o Tracia, e riproposta ai palati romani meno raffinati.
Le favole di Fedro riprendono quelle di Esopo, spesso facendone una traduzione molto libera o riraccontandole da capo. Hanno chiaramente un intento didascalico, ma molto più quotidiano di quello della grande epica, o di quelle che saranno di lì a poco le Silvae staziane. I precetti che contengono sono ben poco adatti all’aristocrazia romana, ma perfetti per tutti coloro che non possono permettersi di accedere agli insegnamenti di maestri di grammatica e filosofi, ovvero una piccola porzione della plebe in crescita e soprattutto schiavi e liberti colti, importati o meno che fossero dalle varie province dell’impero. Se l’eroismo è per pochi, il buonsenso è per tutti, soprattutto quando viene insegnato in modo leggero e disimpegnato; eppure ciò non basterà a garantirgli un vero e proprio successo coevo, proprio in quanto esponente di una classe più umile e rivolto ai suoi consimili.
Resta tuttavia l’unico esempio di espressione del pensiero dei liberti da parte di uno di loro e si rivela piuttosto diverso dai ritratti poco lusinghieri fatti dai cortigiani. Che fosse il pensiero di tutti, o dei più, è difficile dirlo, ma certo, anche questa realtà sociale controversa non può essere ridotta solo ai suoi vizi, o ai vizi dei suoi esponenti più famosi.
Samuele Baracani: nato nel 1991, biellese, ma non abbastanza, pendolare cronico, cresciuto nelle peggiori scuole che mi hanno avviato alla letteratura e, di lì, allo scrivere, che è uno dei miei modi preferiti per perdere tempo e farlo perdere a chi mi legge. Mi diletto nella prosa e nella poesia sull'esempio degli autori che più amo, da Tasso a David Foster Wallace. Su ispirazione chauceriana ho raccolto un paio di raccontini di bassa lega in un libro che ho intitolato Novelle Pendolari e, non contento, ho deciso di ripetere lo scempio con Fuga dai Faggi Silenziosi.