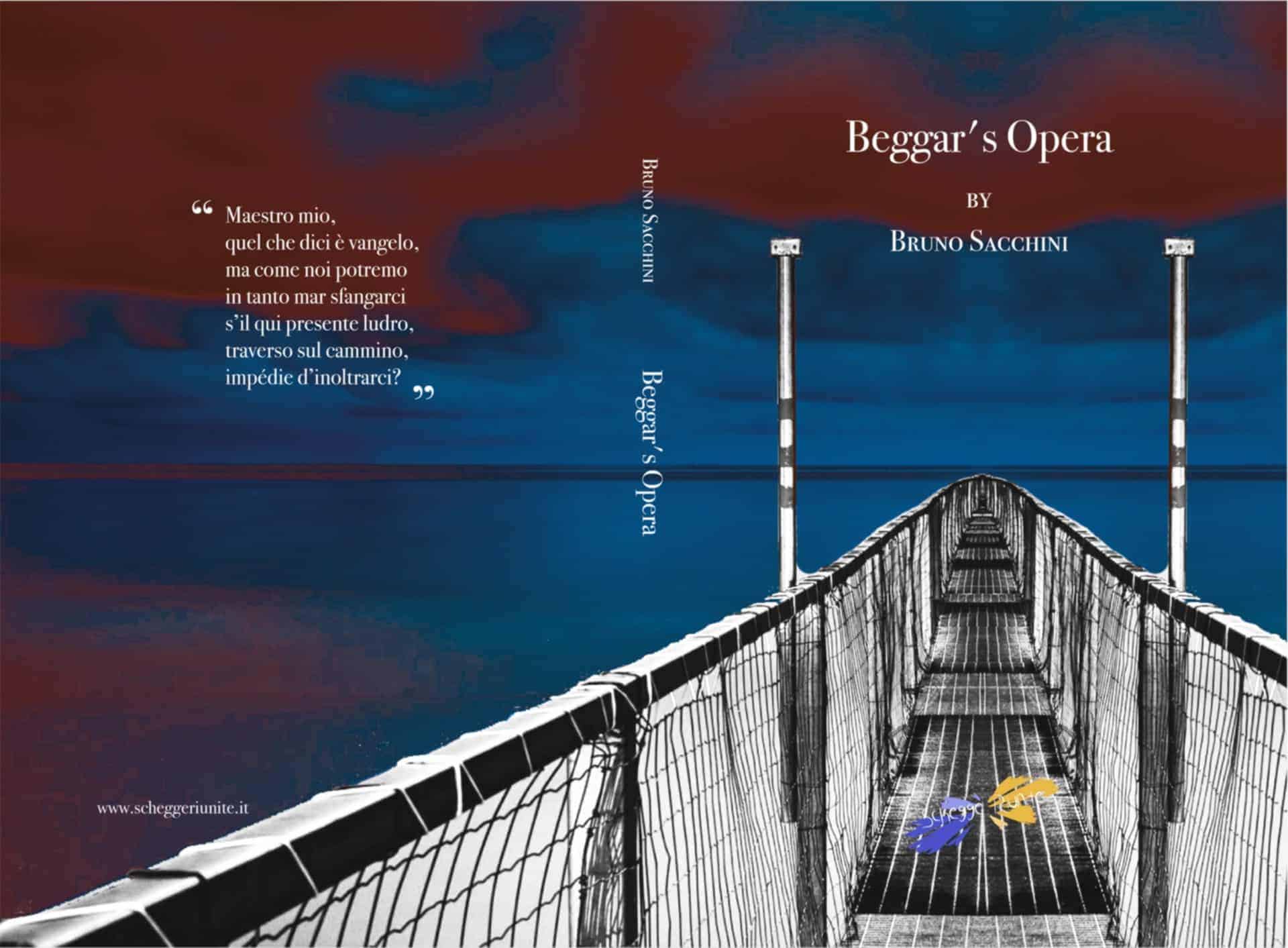Elio Gioanola
Caro Bruno,
Subito, allora, ho aperto l’allegato e mi sono reso conto della portata del tuo impegno di scrittura.
Credo proprio che solo l’incoscienza e la disperazione, ma soprattutto la follia creativa, possono indurre uno scrittore a imbarcarsi in una simile impresa.
Tu sei un Dantista viscerale e molto attrezzato, l’unico che poteva prendere a modello il Poeta esponendosi a rischi incalcolabili che solo uno come te, viator nichilista e futurista, poteva assumersi con adeguato expertise stilistico.
Ti salva il tuo espressionismo incandescente, che fa di Dante un originario predecessore, ma permette di non arrischiare una qualsivoglia forma imitativa.
In fondo il sommo poeta ti suggerisce il punto di vista di un “giudizio universale” sul contesto culturale, politico, ideologico ecc. nel quale siamo immersi, facendosi in questo un riferimento ineludibile, ma non ti obbliga in nessun modo a un viaggio di ricognizione attraverso una fenomenologia di personaggi, situazioni e azioni (o stili) della più diversa natura.
Insomma il tuo, se capisco qualcosa, è un unico Inferno e la tua scrittura è così esasperatamente espressionistica da lasciar intendere che non ci sarà spazio per nessun viaggio verso altre plaghe.
Non mi attento a formulare giudizi, certo la novità è grande, il coraggio temerario, in certe condizioni generali e personali il grido profondo che deforma l’espressività è più che giustificato.
Elio Gioanola
(critico e storico della letteratura)
Gian Franco Morra
Avevo pensato a una traduzione “di” Dante, invece la sua è una riscrittura “da” Dante in un moderno “nobile castello” nel quale si trova, in una “bella schola”, in compagnia di altri “spiriti magni” come Eliot, Testori, Pasolini, non di rado nel solco del futurismo e del surrealismo.
Un linguaggio modernissimo, provocatorio e drammatico nella sua originalissima aggressività ad alta tensione, sempre però memore della compostezza classica.
Sono poesie e prose di rottura e avanguardia, certo apprezzate da chi fa il mestiere della cultura, ma affascinanti anche per la maggioranza di noi comuni mortali.
Gian Franco Morra
(Università di Bologna)
Enzo Pirroni
Caro Bruno,
Ho letto e riletto tutti i canti del tutto Beggar’s Opera e in tutta sincerità ti dico che, pur non essendo io un frequentatore professionale di poesia, me ne sono innamorato.
Ci ho trovato tutto.
Nei tuoi versi c’è un contenuto che è, nello stesso tempo, vivace (anche se l’aggettivo vivace è limitativo) e appassionato, religioso e politico, morale e causticamente blasfemo. In questa tua elaborazione sono scomparse le formule d’uso e le convenzioni poetiche che, inevitabilmente, inficiano una produzione italiota la quale deriva dai maledettissimi poeti novecenteschi, massime gli Ermetici, che hanno contrabbandato per poesia parole poste una sotto l’altra con poca o nessuna cura ritmico-assonanzata, degna d’un virtuosismo da elenco telefonico e basta.
Tu formuli un nuovo, esclusivo contenuto facendo piazza pulita dell’insulso formulario “modernista”. I tuoi versi, calibrati col bilancino dello speziale, escono da una lunga elaborazione secolare e non simulano l’estro o l’impeto disordinato del “poeta ispirato”: si avverte al contrario un travaglio culturale che ti assimila all’arte attenta d’un Rolando Orfei dentro la gabbia dei leoni.
Sei riuscito a imbrigliare in versi una materia tumultuosa, anzi magmatica, e si intuisce che l’hai fatto non senza fatica. Adoperi l’endecasillabo facendogli assumere infinite pose, altrettanto fai con l’esametro. Alterni, mischi, vari gli artifizi poetici della tradizione, maneggi con disinvoltura ogni sorta di figura retorica.
Soprattutto mi ha affascina l’abilità con cui passi dal comico al tragico, utilizzando la larghezza o la cupezza nel suono delle vocali, manipolando con consumata maestria l’impeto delle consonanti.
Attraverso un linguaggio mai banale, usando un registro allusivo e teso all’intarsio che giunge fino alla locupletazione di se stesso, realizzi una operazione wittgensteniana per cui creare un linguaggio equivale a generare nuove forme di vita.
Infine lo sperimentalismo.
Ti inveschi nei dialetti (ma anche negli anglismi, nei giovanilismi, nel formulario digitale eccetera) con spensierata levità, al punto che è proprio attraverso tali forme che riesci, come sosteneva Dossi, ad attribuire una ideale dimensione agli abitatori di questa nostra terra, come fa il suolo con la flora e la fauna.
Enzo Pirroni
(accademico della Crusca)
Daniela Donati
Ho trovato i Canti del tuo viaggio nell’inconscio ultraterreno addirittura ipnotici.
Nel senso che mi hanno indotto a una lettura ripetuta, quasi compulsiva, come se lasciassero intuire la presenza d’un nodo nascosto, d’un garbuglio che l’ambivalenza costante della tua scrittura sottende come promessa e che io ero autorizzata a cercar di sciogliere dall’enigma.
Forse l’ascolto, cui l’intera opera sembra destinata assai più che la lettura, avrebbe maggiormente aiutato.
Ho ritrovato nel tuo poetare “torrentizio” una sorta di movimento, di andamento in qualche modo subliminale.
Tutto procede in senso verticale, a mo’ di discesa e salita continua: la lotta fra angeli e demoni in contesa, lo sprofondare della fossa, l’ingorgo, la salita cliffhanger mano a mano, lo scendere la china seguendo il corrimano, il cadere dall’alto al basso nel budello come nell’utero partoriente…
Con in più suggestioni circolari, talora morbide (gli abbracci mancati e quelli fatti di pianto, il moto immaginario della cuna) talora zigzaganti e centrifughi come il rugghio che esplode, gli schizzi, le stecche di fiato gettate in viso, il ballonzolare fuori, il gattonare dei personaggi, il terremoto che spacca, gli sbrindelloni a caso…
Il canto XXV, per fare un esempio, nel suo essere struggente ha il dono di rendere paradossalmente pacificanti e universali i termini d’un dialogo drammatico e personalissimo.
Gli ultimi nove versi, poi, sono un abbraccio nell’abbraccio, una voluta.
Nel suo essere cinematografico e cruento, ho trovato poi il XXXI repulsivo e nello stesso tempo attraente come lo sono tante cose repulsive e al tempo stesso attraenti, in particolare l’idea delle madri costrette a nutrire i figli col loro sangue sentendoli ancora mostricini, alieni, pur baloccandoli sulla pancia in una caricatura drammatica e sanguinolenta dei gesti materni di tenerezza.
Non-madri in eterno.
Daniela Donati
(scrittrice)
Ronaldo Bertozzi
Rileggendo i tuoi Beggar’s si conferma e si rafforza la mia idea che tu abbia scritto un’opera di vitalità e complessità straordinarie. Direi che tra le sue caratteristiche più importanti è la non finitezza, intesa come assenza di confini e limiti definiti, di perimetro misurabile, ragion per cui non è consentito circoscriverla e dominarla mentalmente, né al lettore né – ovviamente – al suo autore.
Quando mi infilo in un’opera ordinaria, percorro un tunnel/galleria/corridoio le cui dimensioni sono perfettamente definite dalla distanza che separa la prima riga dall’ultima. Tale distanza misura anche l’unico percorso reale possibile (e ne definisce l’unico senso di marcia) perché sulle pareti della galleria si succedono fondali teatrali di cartapesta, scorci dipinti, trompe d’oeil, falsi varchi che non ti portano da nessuna parte.
Al contrario, se mi avventuro (con tutta la circospezione del caso) in Beggar’s Opera, devo fare molta attenzione a dove metto i piedi : è un susseguirsi di botole che possono inghiottirmi da un momento all’altro, di lucernai e di finestre vere, che se le attraverso penetro in un interstizio, in un labirinto meta-para-testuale dal quale potrei non riuscire a tornare indietro. Ma, se torno, soltanto io posso raccontarti cosa c’era là fuori per me, chi ho incontrato. Sì, tu lo hai scritto, dal primo all’ultimo verso e lo hai anche limato e lucidato, ma sai bene che Beggar’s esce dal tuo controllo e, se vorrai conoscere tutto di lui, ti sarà indispensabile l’aiuto di coloro che riusciranno a leggerlo.
Insomma c’è da invidiare il tuo futuro scopritore ed esegeta, ed anche ammirarne l’intelligenza e il coraggio. Lo chiameremo, per ora, dr. Aladdin Levi. Non è impossibile prevedere quali nodi dovrà sciogliere, ma con quanto successo è un altro paio di maniche.
Immagino che giudicherà architravi (con funzioni diverse) dell’opera i canti in forma di dialoghi teatrali (XV e XIX) ed il XVIII, biografia fantastica in prosa torrentizia. Introducendo la quale tu glissi, limitandoti ad un “alleggerendo un poco il logorio del verso” ma il nostro interpreterà saprà che la tua vera intenzione, la tua necessità, – quando è cruciale che il lettore intenda – è quella di non asconder la dottrina sotto il velame delli versi strani. E dunque in questi tre Canti scaverà per cercare le chiavi che spera gli apriranno i recessi più controversi degli altri.
Tu lo inviti al gioco delle lettere che designano i dialoganti, e lui non si fa pregare.
Levi sviluppa l’idea (magari balzana) che A e B nel XV vadano intese come le prime due lettere dell’alfabeto, benché B abbia anche il valore di iniziale reale; mentre nel XIX G e C sarebbero ambedue lettere iniziali. Ma, se C è trasparente, sulla G Levi si incarta.
Ostenta invece idee più chiare sul XVIII, in cui l’autore inventa e tumultuosamente illustra con violente spatolate (qui lo spericolato commentatore cita Guernica e arditamente lo lega con un filo ad A. del XV) una giovinezza forsennata. Perche? Perché – dice lui – tanto viaggio non potrebbe essere pensato intrapreso sopportato da un’anima bella né potrebbe materializzarsi e rompere gli ormeggi in tabula rasa.
Ronaldo Bertozzi
(medico umanista)