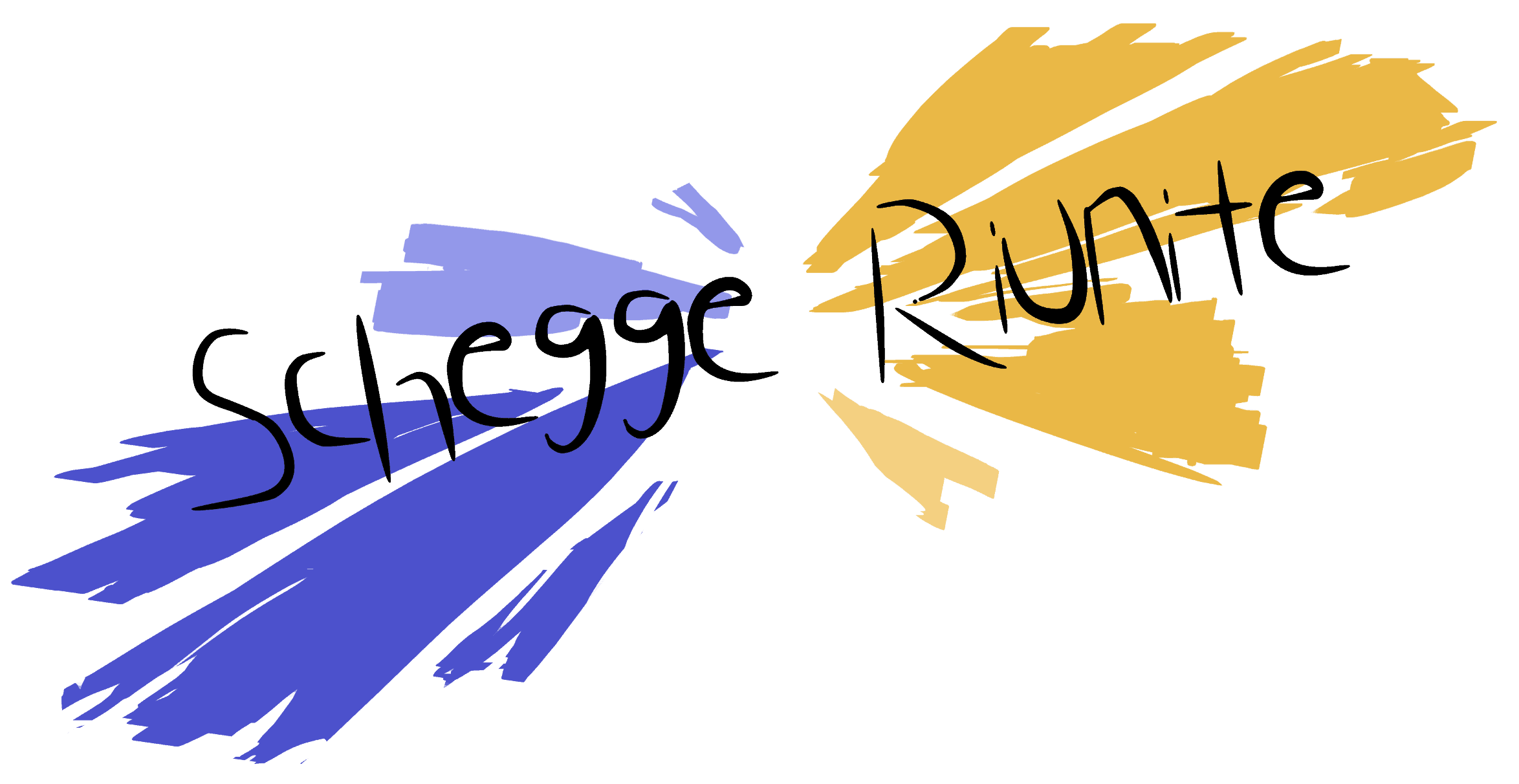Il pretino sui pattini | mienmiuaif & bra
“Ordinarie follie” di Edoardo Dantonia
“Torò-torò, torò-torò”, sento canticchiare alle mie spalle mentre saluto un mio amico dopo un pomeriggio passato a casa sua. Appare da dietro la cancellata una figura sensazionale nella sua piccolezza: un minuscolo prete di novant’anni che pattina, letteralmente, verso casa, bastone alla mano. I capelli hanno abbandonato da tempo il suo cranio, e l’età ha piegato le sue membra; eppure ho trovato molta più vivacità in questo vecchio pretino che in tanti miei galiardissimi amici. Il singolare soggetto sta da questo mio amico da qualche anno ormai, ma io non ricordo il suo nome, e temo di non averlo mai nemmeno chiesto. Giunge accanto a noi, che ci stavamo congedando all’uscita, e mi dice: “Sei cresciuto troppo per i miei gusti”. Io gli rispondo sorridendo: “Cercherò di fermarmi allora”. Lui fa ancora qualche passettino, ci supera e poi mi dice, girandosi: “Allora, quando ti fai prete?”. Io rido e gli dico: “Guardi, a meno che arrivi la chiamata dall’alto, penso sia molto improbabile”. Il pretino sorride e poi chiede ancora: “Ma tu la dici la corona?”. Io mi imbarazzo e dico: “Qualche volta”. Lui allora s’infervora un poco e mi redarguisce: “Tu mangi tutti i giorni? E Jahvè c’è tutti i giorni? Allora perché non dici la corona tutti i giorni?”. Io rimango in silenzio aprendo le braccia, come per dargli ragione, e lui in un attimo tira fuori da non so dove un piccolo sacchetto di stoffa e, accompagnando il gesto con il solito “Torò-torò, torò-torò”, fa scivolare fuori più di dieci anelli rosario. “Scegli”, mi dice. Io allungo la mano e ne prendo uno. Il pretino prosegue: “Ora dovrai dire la corona ogni giorno. E la prima volta che la dirai dovrai dedicarla ai sacerdoti, ché ce ne sono pochi”, e se ne va così com’era apparso: pattinando sul terreno e poggiando il suo bastone ogni serie di passettini.
Quel che mi ha detto è qualcosa dettato sicuramente da una sincera preoccupazione e non da una semplice fissa per il sacerdozio. Aggiungo anche che la prima delle corone che ho detto l’ho davvero dedicata ai sacerdoti. Ma non l’ho fatto perché questi aumentino di numero, bensì perché quelli già esistenti svolgano al meglio la loro missione. Non penso infatti che il trionfo di Cristo sia qualcosa di visibile attraverso mere vittorie terrene: un saldo potere ecclesiastico, una ingente quantità di ordinazioni, etc. D’altronde non lo pensa nemmeno la Chiesa, che nel suo Catechismo dice: “Il Regno non si compirà dunque attraverso un trionfo storico della Chiesa secondo un progresso ascendente, ma attraverso una vittoria di Dio sullo scatenarsi ultimo del male che farà discendere dal cielo la sua Sposa”*. Cristo non venne infatti con una corona d’oro poggiata in testa a spodestare i malvagi, ma subì la più tremenda delle pene e la più bassa delle umiliazioni. La sua corona fu di dolorosissime spine. La storia della Chiesa cominciò con quella che possiamo a tutti gli effetti definire una sconfitta. Ma da quella sconfitta terrena nacque una vittoria celeste, la vittoria della vita sulla morte. Se oggigiorno vediamo chiese vuote, o persino demolite, fedeli confusi, preti indegni o assenti, valori spezzati e via dicendo, non solo non dobbiamo disperare, ma dobbiamo esultare persino: se la Chiesa trionfasse in terra dovremmo ragionevolmente aspettarci che, da un momento all’altro, essa possa cadere e scomparire del tutto, come tutte le cose che trionfano nel mondo.
*(CCC; 677)
Edoardo Dantonia: classe 1992, sono il più giovane e il più indegno di questo terzetto di spostati che si fa chiamare Schegge Riunite. Raccontavo storie ancor prima di saper scrivere, quando cioè imbastivo veri e propri spettacoli con i miei pupazzi, o quando disegnavo strisce simili a fumetti su innumerevoli fogli di carta. Amante della letteratura, in particolare quella fantastica e fantascientifica, il mio sogno è anche la mia più grande paura: fare della scrittura, cioè la mia passione, il mio mestiere.