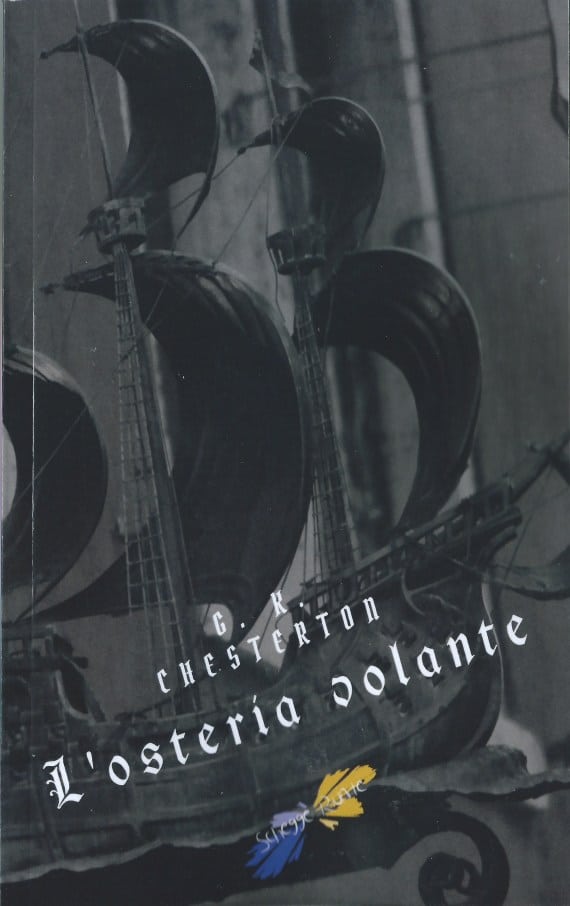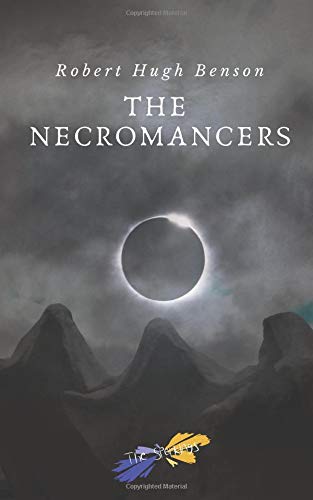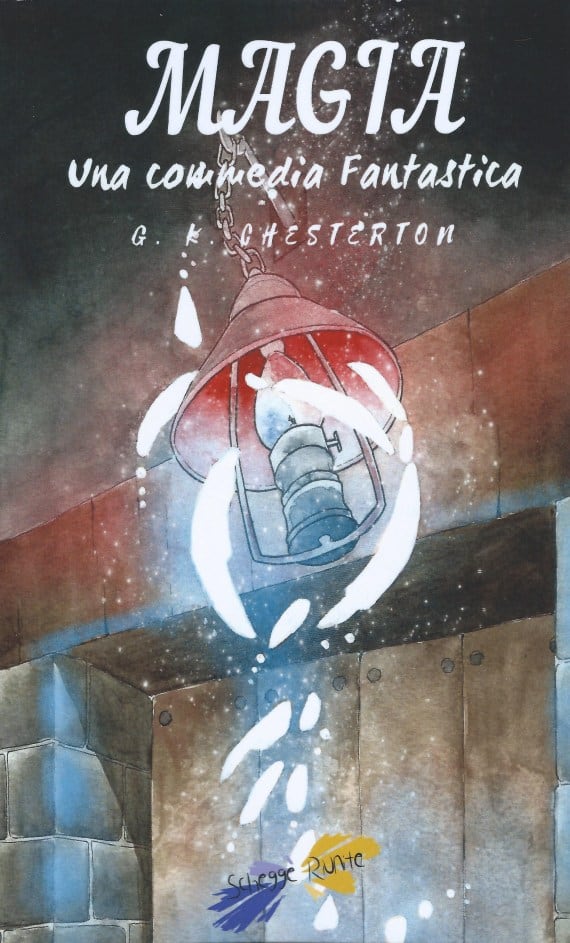L’Impero britannico, dopo una lunga e logorante guerra, decide di abbassare le armi e di consegnarsi all’imbattibile avversario islamico. Vengono così introdotti in Inghilterra i costumi orientali che, tra le altre cose, prevedono il divieto di bere alcolici. Alla conseguente distruzione delle taverne sopravvive solo un’insegna, quella della locanda “La vecchia nave”, la quale, raccolta dal marinaio irlandese Patrick Dalroy – che mal sopporta l’idea di dover diventare astemio –, si tramuta nella bandiera di una rivolta destinata ad estendersi all’intera nazione.
Queste le funamboliche premesse contenute nell’epilogo de L’osteria volante (1914), uno dei romanzi più famosi di G. K. Chesterton, appena ripubblicato dal sodalizio culturale “Schegge Riunite” (edizione a cui sono felice di aver contribuito con una breve prefazione).
Il conflitto di civiltà descritto nel libro, per quanto profetico, ha poco a che vedere con i macchiettistici dibattiti politici contemporanei. Chesterton e i suoi paradossi non si scagliano esclusivamente contro la religione islamica, piuttosto mettono alla berlina il nichilismo che contagia la moderna cultura occidentale, un desiderio suicida per il nulla che sovente si intreccia con suggestioni filosofiche provenienti dall’Oriente. La vera lotta, dunque, prima di acquistare una fisionomia sociale, è innanzitutto quella contro la tentazione che si consuma nell’anima di ogni uomo. «Militia est vita hominis super terram»: è per questo che Dalroy decide di non arrendersi e di continuare a combattere; non è solo questione di libertà, di più, è questione di eternità.
Con una punta di malcelata ironia, spetta all’alcol il compito di risvegliare le coscienze, di risollevare le sorti di una terra ormai ridotta a una landa di spettri. L’impossibilità di consumare birra è la scintilla che dà il la a una rivolata che è un contagio positivo che riaccende menti e cuori. Per la sua impresa donchisciottesca Dalroy ha solo bisogno di un’insegna a mo’ di vessillo, di una forma di cacio, di un barilotto di rum («è un patrimonio sacro dell’umanità e noi ne berremo solo per celebrare grandi vittorie»), dell’amico Humphrey Pump e del cane Quoodle. Non serve altro per conquistare il mondo, basta una truppa di volenterosi – perché le vere avventure sono tali solo se condivise – e il gioco è fatto.
La compagnia muove i propri passi in terra inglese con il cuore colmo di una gioia e di un amore che sono sconosciuti all’antagonista Lord Ivywood e a quelli della sua risma, la stessa gioia e lo stesso amore che danno fiato alle bocche di Dalroy e dei suoi per intonare canti a squarciagola. Da dove venga questo buon umore è presto detto: dal riconoscersi creature, misere eppure gloriose, che dipendono da un Bene trascendente con il quale si tenta, pur tra mille limiti, di instaurare una relazione.
Questo è il motore dell’impresa compiuta dai protagonisti, la cui sola presenza, sgangherata ma spiritualmente autentica, non può passare inosservata e lasciare indifferenti. È dunque nel rapporto, non in altro, che ha posto la vera libertà, quella bellezza che salverà il mondo.
Il libro: G. K. Chesterton, L’osteria volante, Schegge Riunite, 2018, 260 pagine, Euro 11.
Link all’acquisto: